
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
In questa sezione di ESIA-
Italia curata dal dott. A.PIGNATARO
sarà ospitata la descrizione ed il relativo commento di
un caso di intossicazione acuta.
INTOSSICAZIONE
ACUTA DA CLORALOSIO: IMPIEGO DELL'EMOFILTRAZIONE ARTERO-VENOSA
CONTINUA (CAVH) NELLA RIMOZIONE DEL TOSSICO
Lanza V., Pignataro A., De Michele P., Baldi M.L.*, Locatelli C.°
Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Buccheri La Ferla, Fatebenefratelli, Palermo, Italy
* Servizio di Medicina Legale e Tossicologia, Policlinico S. Matteo I.R.C.S.S., Pavia, Italy
° Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica, Fondazione Clinica del Lavoro I.R.C.S.S. Pavia,
Italy
Introduzione
Il cloralosio, sostanza ottenuta
dalla combinazione di una molecola di cloralio e di una di glucosio,
viene impiegato come rodendicida organico di sintesi, ed è
commercializzato in Italia in apposite esche ed in polvere. Un
altro derivato del cloralio, l'idrato di cloralio, viene impiegato
diffusamente nei paesi anglosassoni come sedativo-ipnotico non-barbiturico
per l'induzione dell'anestesia gemerale. L'assunzione di grosse
quantità di derivati del cloralio, per lo più volontaria,
è causa di gravi intossicazioni con effetti depressivi
sul SNC (corteccia e sostanza reticolare), sull'apparato respiratorio
e su quello cardiovascolare. In massive overdoses l'idrato di
cloralio presenta un' emivita prolungata da 8 a 35 ore e la depurazione
extra-corporea mediante emodialisi può essere efficace
nel rimuovere fino al 34% dei depositi corporei (1). Nel caso
clinico qui descritto, un'intossicazione acuta di cloralosio è
stata trattata con l'emofiltrazione artero-venosa continua (CAVH)
della durata di 2 giorni.
Caso clinico
Nel giugno 1994, una giovane donna di 23 anni veniva accompagnata dai familiari al Pronto Soccorso dell'Ospedale priva di coscienza, in preda a crisi convulsive e difficoltà respiratoria. All'esame neurologico, la donna presentava un Glasgow Coma Score pari a 7, non rispondeva allo stimolo verbale, e manifestava mioclonie e crisi convulsive alla minima stimolazione. La paziente era cianotica, con fasi d'apnea consecutive agli episodi convulsivi; scialorrea e broncorrea complicavano il quadro respiratorio. La determinazione dei gas del sangue rivelava una grave ipossiemia (pO2 48 mmHg), ipercapnia (pCO2 50 mmHg) ed acidosi respiratoria. La pressione arteriosa era di 90/50 mmHg e l'ECG mostrava una tachicardia sinusale (130 battiti/min) interrotta da frequenti extrasistoli sopraventicolari. Lo stato neurologico e le condizioni ventilatorie motivavano l'intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica a pressione positiva ad elevata FiO2. Le mioclonie e le crisi convulsive imponevano boli ripetuti di diazepam e di propofol. Il racconto dei familiari della donna svelava l'assunzione volontaria, in epoca imprecisata, del contenuto di una bustina (3,3 g) di un ratticida (Murex), a base di polvere di cloralosio al 62,5%. La donna, in preda ad una grave sindrome depressiva per la morte recente del marito, era al terzo tentativo di suicidio. La pz. veniva quindi sottoposta al lavaggio gastrico, con sospensione di carbone attivato, e alla catarsi salina. La persistenza del quadro neurologico, emodinamico e respiratorio motivavano il trasferimento della pz. in terapia intensiva dove veniva proseguita la ventilazione meccanica a pressione positiva ed instaurata una terapia infusionale con cristalloidi previo incannulamento di una vena centrale. Il susseguirsi degli episodi convulsivi imponeva dosi subentranti di diazepam , ma soltanto l'impiego di propofol in infusione continua (200 mg/h) permetteva il controllo dello stato convulsivo. Il perpetuarsi dello stato ipotensivo (PAO 90/60 mmHg) richiedeva il riempimento vascolare con gelatina (Emagel 1000 ml) e l'uso di un inotropo (dobutamina 5 mcg/kg/min). Il grave quadro clinico, la quantità di cloralosio ingerita superiore alla dose minima letale per un adulto (2), e le caratteristiche farmaco e tossicocinetiche del tossico, motivavano il ricorso alle tecniche di depurazione extra-renale. La scelta dell'emofiltrazione artero-venosa continua (CAVH) era motivata dalle precarie condizioni emodinamiche della pz. che non avrebbero consentito l'impiego delle tecniche depurative tradizionali (emodialisi) e dalla relativa semplicità d'uso della tecnica che ne permetteva l'applicazione immediata al letto della pz. Il Kit di emofiltrazione utilzzato, (GAMBRO AV 66), consisteva di un filtro a fibre cave, di una cannula arteriosa, di una venosa di un circuito arterioso e di uno venoso.

| Fig.1. Kit per emofiltrazione continua arterovenosa (CAVH). Click sulla figura per avere una spiegazione dettagliata.(poi click sul pulsante BACK per tornare al testo) |
Il sistema veniva assemblato previo incannulamento dei vasi femorali. Il liquido di emofiltrazione a composizione elettrolitica nota, regolato da una pompa volumetrica peristaltica (Abbott), era infuso con il metodo pre-diluzionale (pre-filtro). Una seconda pompa garantiva la produzione oraria d'ultrafiltrato voluta. L'anticoagulazione del sistema era ottenuta con l'infusione di eparina (500 UI/h all'inizio, poi secondo i valori del PTT) tramite pompa-siringa. La quantità di ultrafiltrato nelle 24 ore (500 ml/h) è stata di 12 litri. La sospensione della sedazione continua dopo circa 30 ore dall'inizio della CAVH ha permesso la ripresa della coscienza con completa risoluzione dello stato convulsivo, mentre l'interruzione dell'emofiltrazione avveniva dopo circa 48 ore. Il recupero dell'attività respiratoria spontanea della pz. ne permetteva l'estubazione , mentre la dimissione avveniva dopo 5 giorni dal ricovero senza reliquati neurologici in ottime condizioni generali.
Campioni di sangue e di ultrafiltrato,
basali, dopo 2, 8, 14 e 21 ore dall'inizio dell'emofiltrazione,
sono stati prelevati per la determinazione dei livelli di cloralosio.
Non è stato effettuato alcun prelievo dell'urina prodotta.
Non è stato possibile, inoltre, collezionare il materiale
raccolto dalla gastrolusi.
Risultati
I livelli di cloralosio nel plasma e nel filtrato sono riportati in tabella 1 :
| Tab.1.Livelli di cloralosio | ||
| plasma (mcg/ml) | filtrato (mcg/ml) | |
| 0 | 12 | 0 |
| 2 | 8 | 2,5 |
| 8 | 1 | 0,5 |
| 14 | 0,1 | 0,1 |
| 21 | 0 | 0 |
Il tricloroetanolo e l'acido tricloroacetico,
metaboliti del cloralosio e ritenuti responsabili degli effetti
tossici del cloralio e dei suoi derivati, non sono stati riscontrati
nei liquidi in esame.
Discussione
Le tecniche di rimozione extracorporea differiscono grandemente nella capacità di allontanamento di una sostanza. Il principio fisico dell'emofiltrazione, la convezione, determina lo spostamento di un fluido e dei soluti in esso contenuti attraverso una membrana semi-permeabile, secondo un gradiente di concentrazione (processo simile alla filtrazione glomerulare). Il trasporto per convezione è in grado di rimuovere molecole di dimensioni maggiori di quanto non sia possibile con la diffusione sfruttata durante emodialisi, e questo potrebbe giustificare l'impiego clinico dell'emofiltrazione nell'allontanamento delle sostanze tossiche. Le metodiche emofiltrative continue artero-venose (CAVH) e veno-venose (CVVH), così come l'emodiafiltrazione artero-venosa continua (CAVD-H), impiegate già in rianimazione nei pazienti critici per correggere alterazioni idroelettrolitiche, insufficienze cardiache congestizie e sindromi d'insufficienza multipla d'organo, possono presentare alcuni vantaggi nel trattamento delle intossicazioni acute. La rimozione continua giornaliera di 15-20 e più litri di filtrato permette la clearance di grandi quantità di soluti. Inoltre, la continuità della metodica può controbilanciare gli effetti rebound che si verificano comunemente con le tecniche intermittenti di emodialisi o di emoperfusione. Le indicazioni alle tecniche continue potrebbero essere estese a quelle sostanze ritenute dializzabili ma dotate di alto volume di distribuzione e pertanto non aggredibili con le metodiche extra-renali intermittenti.
Nel caso qui riportato la scomparsa
del cloralosio dal sangue ha seguito una retta di decadimento
con un slope di -0.55 ed una costante di tempo di -1,83. La completa
scomparsa dal siero si è ottenuta dopo 20 ore dall'inizio
della CAVH. I valori di cloralosio nell'ultrafiltrato hanno mostrato,
che con una velocità di estrazione di 500ml/hr è
stato possibile estrarre 1.25 mg/hr quando la concentrazione sierica
era di 8 mcg/ml, 0.25 mg/hr con una concentrazione sierica di
1mcg/ml e di 0.05mg/hr con una concentrazione sierica di 0.1 mcg/ml.
Questo testimonia una capacità depurativa interessante
della CAVH nei confronti del cloralosio. I "classici"
metaboliti del cloralosio, il tricloroetanolo e l'acido tricloroacetico,
ritenuti responsabili degli effetti tossici del cloralio e dei
suoi derivati, non sono risultati presenti nei liquidi in esame:
questo mancato ritrovamento potrebbe aprire un nuovo aspetto della
tossicocinetica di queste sostanze.
Conclusione
Sebbene i presupposti teorici siano interessanti nel prospettare le tecniche di emofiltrazione continua come strumenti depurativi efficaci nell'allontanamento di un tossico, le applicazioni cliniche delle depurazioni continue sono pochissime e richiedono chiare dimostrazioni di validità nelle intossicazioni acute. Tutti gli studi sinora condotti sulla rimozione di sostanze con le tecniche extracorporee continue riguardano agenti terapeutici (4).
La nostra esperienza con la CAVH sembra
offrire una valida alternativa alle tecniche "tradizionali"
sia in termini di efficacia che in termini di costo/beneficio
e potrebbe contribuire, pertanto, ad un maggiore interesse nei
confronti di tali metodiche in ambito tossicologico.
Bibliografia
1. Hoffman R.S, Goldfrank L.R. Critical Care Toxicology. Churchill Livingstone, 1991 pag. 79
2. Bozza Marrubini M., Ghezzi Laurenzi R., Uccelli P. Intossicazioni Acute. OEMF 2a Edizione, 1989 pag. 308-310
3. Stalker N.E., Gambertoglio J.G., Fukumitsu C.J., Naughton J.L., Benet L.Z. Acute massive Chloral hydrate intoxication treated with hemodialysis: a clinical pharmacokinetic analysis. The Journal of Clinical Pharmacology 136-142, February-March, 1978
4. Golper T.A., Bennet W.M. Drug removal
by continuous arterovenous haemofiltration. Medical Toxicology
3: 341-349 (1988)
____________________________________________________________
4 MANUALI DI ANESTESIA:Anestesia
in Ortopedia (2a parte)
___________________________________________________________________________
Questa rubrica, curata dal dott. Lelio Guglielmo, presenta i protocolli anestesiologici adottati ,nelle varie specialità chirurgiche , dal Servizio di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale Buccheri La Ferla. Questi manuali che sono il frutto di studi e dell'esperienza di oltre 15 anni di attività anestesiologica non pretendono ovviamente di avere un carattere "universale" . E' evidente altresì che l'applicazione delle procedure descritte va valutata criticamente in relazione al proprio ambiente di lavoro. La parte riguardante le considerazioni chirurgiche è stata realizzata in collaborazione con i chirurghi delle varie specialità, operanti nel nostro ospedale.
Qualsiasi commento o critica è
bene accetta e deve essere inviata a leliobuc@mbox.vol.it. oppure
alla redazione LANZA@mbox.unipa.it
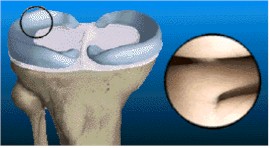 | PROTESI DI GINOCCHIO | |
 |
Le osteoartriti sono le indicazioni più comuni per questo intervento. Nel caso di pazienti affetti da artrite reumatoide valgono le stesse considerazioni già viste nei pazienti sottoposti a protesi di anca. (Esia-ottobre 96.) | |
Considerazioni chirurgiche
In questa procedura, attraverso l'artrotomia del ginocchio, viene inserita una protesi di parti metalliche e plastiche al posto delle superfici articolari del ginocchio che vengono resecate. Attraverso una incisione verticale vengono esposte il femore, la patella e la tibia. Le estreme parti distale del femore e prossimale della tibia vengono resecate con una sega. Dopo preparazione e appropriato allineamento dei segmenti ossei le parti della protesi vengono inserite nella estremità distale del femore e prossimale della tibia. Esse possono essere cementate o meno. La patella viene riallineata. Alla fine vengono posizionati i drenaggi e suturati i tessuti sottocutanei e cutanei.
Usuale diagnosi preop.: Artrite e artrosi del ginocchio;
SOMMARIO DELLE PROCEDURE
Posizione supina
Incisione anteriore, verticale
Consideraz.speciali Tourniquet (viene posizionato ma non utilizzato). Alla fine dell'intervento viene collegato ai drenaggi il dispositivo SOLCOTRANS per il recupero del sangue drenato
Antibiotici Ceftriaxone 2gr.
T.chirurgico 2-3 h.
Perdite ematiche 300-750ml
Mortalità minima
Morbidità Trombosi venosa profonda:
-senza profilassi: 50-75%
-con eparina :10-20%
Sublussazione di patella: 30%
Infezione della ferita: 5%
Embolia polmonare: 1-7%
Revisione dell'intervento (dopo 10a.:5%)
Lesione N.peroneale: 1-5%
Ematoma: 1%
Scala dolore 8-9
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DEI PAZIENTI
Età: >60a.
Incidenza 10.000/a. in Italia
Eziologia Artrosi
Artrite con varismo o valgismo
Artropatia emofilica
Considerazioni anestesiologiche
PREOPERATORIO
Per quanto riguarda la valutazione preoperatoria dei sistemi respiratorio, cardiovascolare, renale etc. consultare la sezione riguardante il preoperatorio dei pazienti sottoposti ad endoprotesi d'anca (Esia-ottobre 96.)
Premedicazione della veglia: trattandosi spesso di pazienti non molto anziani (50-60a.) può essere utile somministrare 1-2 mg di Lorazepam la sera e la mattina dell'intervento.
INTRAOPERATORIO
Premedicazione: Standard
Emodiluizione : Secondo protocollo. Molti pazienti effettuano una donazione prima
dell'intervento
Dobutamina : Iniziare l'infusione continua, nei pz più a rischio, dopo la
premedicazione
Anestesia : AP o AS a seconda delle condizioni anatomiche del rachide.
Normalmente si utilizza una dose di 12-15mg di Marcaina 1%iperbarica
associata a 0.3 ml di adrenalina (vol.tot.di 1.5-1.8ml).
E' adeguata una estensione dell'anestesia tra T12 e S5.
Cateteri venosi : 1 venflon grigio 16g , 1 venflon rosa 20g (per la dobutamina).
Perdite ematiche: Verifcare l'Hb durante l'intervento e nel post-operatorio
Monitoraggio : ECG, SaO2, tcPO2-PCO2, pa cruenta, diuresi oraria
Sedazione : Diprivan 7-15 ml/hr
Complicanze: Trauma dell' a.tibiale posteriore
Paralisi postoperatoria del territorio del N.peroneale
POSTOPERATORIO
Complicanze: Emorragia dall'a.tibiale posteriore
Paralisi n.peroneale
Analgesia postop: Infusione peridurale continua con Marc.0.3% a 6-9ml/hr oppure
Infusione femorale continua (se AS) con Marc.0.3% a 6ml/hr
+ Diclofenac 75mg.x 2 IM. Il blocco femorale viene praticato subito dopo
l'arrivo del paziente in Sala Risveglio.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Informazioni sulla rivista
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE-Italia-
Educational Synopses in Anesthesia and Critical Care Medicine-Italia costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo.A cura della redazione sarà inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese.La rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta
inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione italiana" indirizzato a LANZA@MBOX.UNIPA.IT
La rivista pubblica rewiews e lavori originali compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici. Le reviews includono argomenti per l' Educazione Medica Continua (EMC), articoli di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed anche brevi comunicazioni.La guida per gli autori può essere consultata collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo:
http://mbox.unipa.it/~lanza
utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia
Oppure può essere richiesta inviando un messaggio a
lanza@mbox.unipa.it
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana
E' anche ottenibile attraverso World-Wide Web WWW: L' URL per questo numero di ESIA è:
http://mbox.unipa.it/~lanza/esiait/esit9611.txt
Il nome della rivista è
esitaamm, dove aa è l'anno ed mm il mese
(per esempio questo numero è esit9611.txt)
LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA
DIRETTORE
Vincenzo LANZA
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo LANZA@MBOX.UNIPA.IT
Terapia Intensiva
Antonio Braschi
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1
Policlinico S. Matteo - IRCCS Pavia
Anestesia Cadiovascolare
Riccardo Campodonico
Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica
Azienda Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it
Anestesia e malattie epatiche
Andrea De Gasperi
Gruppo trapianti epatici / CCM
Ospedale Niguarda - Milano
Medicina critica e dell'emergenza
Antonio Gullo
Professore di Terapia Intensiva
Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva-Università di Trieste
Anestesia ed informatica
Vincenzo Lanza
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo
Tosssicologia
Carlo Locatelli
Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di Pavia
Fondazione Scientifica
"Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"
Pavia
Terapia Antalgica e Cure Palliative
Sebastiano Mercadante
Aiuto del Servizio d'Anestesia e Rianimazione
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo