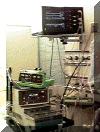_______________________________________________________
La Sala Accoglienza dell'UTIR:
organizzazione infermieristica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo
_______________________________________________________
G. Cardinale, IP
Ospedale Buccheri La Ferla, FBF - Palermo
La strutturazione di un reparto
di rianimazione deve essere fatta prevedendo l’intenso e convulso lavoro che si
deve svolgere al suo interno che non deve essere ostacolato da corridoi stretti o
parzialmente occupati da armadi e apparecchiature di vario tipo.
Alla ricerca di una uniformità dei requisiti strutturali delle terapie
intensive, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI), ha emesso delle raccomandazioni nelle quali sono contenute,
tra l'altro, le caratteristiche della zone assistenziale, quelle cioè destinate
al ricovero e alla cura dei pazienti critici; mancano, tuttavia, riferimenti ad
un'area di fondamentale importanza in terapia intensiva, ovvero quella destinata
alla prima accoglienza dei pazienti. La sala accoglienza rappresenta, infatti,
la cerniera tra i reparti di emergenza, la sala operatoria e in generale tutte
quelle aree nelle quali il paziente riceve il primo trattamento, ed il
reparto di terapia intensiva vero e proprio.
Nella nostra terapia intensiva,
al momento del ricovero (tranne
quello che riguarda i pazienti che giungono dalla nostra sala operatoria) il paziente non viene portato
direttamente nel posto letto ma accolto in ”sala
accoglienza”, dove è possibile assisterlo (spesso per molte ore) anche se in
condizioni molto critiche.
In questa sala si trovano materiale ed
apparecchiature necessari per l’assistenza.
Al suo interno troviamo:
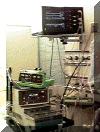 |
-1 presa ossigeno (colore bianco) |
| - prese elettriche |
| -1 presa aria compressa (bianco-nero) |
| -1 presa vuoto (giallo) |
| tavola
rigida per il massaggio cardiaco |
| 1 fonendoscopio |
| 1 pallone Ambu |
| 1-2 pompe a siringa |
| 1 monitor completo |
| 1 monitor da trasporto |
| 1 respiratore meccanico |
| 1 lettino da trasporto
con respiratore meccanico |
| 1 elettrocardiografo per
registrazione ECG su carta |
| Armadio con soluzioni
varie e materiale per medicazioni |
| 1 carrello completo di
farmaci e materiale vario;tubi endotracheali, filtri antibatterici,pinza di Magil,mandrino
intubatore,cannule naso-faringe,cannule di guedel,lubrificante,cateteri vena
centrale,cateteri arteriosi,cateteri vescicali,sondini naso-gastrici,sondini per
ossigeno,sondini per aspirazione controllata, nelaton, provette per esami ematochimici
e di microbiologia |
Questa struttura così
organizzata evita di allontanarsi dalla sala accoglienza per andare a cercare
materiale interrompendo l’assistenza al paziente. Quella dell’accoglienza è
infatti una fase molto delicata sia per i pazienti già presenti in reparto
(durante l’accoglienza infatti vengono meno il medico ed almeno un infermiere
che si devono dedicare al nuovo paziente) che per il nuovo paziente di cui si
conosce poco delle sue condizioni generali ed al quale bisogna assicurare la
stessa assistenza offerta agli altri pazienti.
Come abbiamo organizzato la Sala
Accoglienza
nell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo:
protocolli e procedure
Definizione protocollo
Il protocollo è un documento scritto creato da medici ed infermieri e scaturisce
da studi, ricerche e conoscenze cliniche.
La descrizione scritta serve per:
1)Omogeneizzare i comportamenti del personale;
2)Renderli consultabili e pertanto valutabili;
3)Garantire una corretta conoscenza basandosi sulle più recenti acquisizioni
teoriche e pratiche;
4)Consentire l’adeguamento dei comportamenti alle conoscenze disponibili
(revisione quando è necessario).
Caratteristiche di un protocollo
-Essere naturalmente corretto;
-Essere applicabile (un protocollo deve essere creato in base al materiale che
si ha a disposizione);
-Consentire di capire il perché dell’innovazione o del comportamento proposto;
-Essere condiviso,discusso ed accettato da tutti e non imposto;
-Essere modificabile;
In questo modo il protocollo può essere considerato un buon strumento di
valutazione della qualità delle cure e può essere utilizzato in processi di
qualità dell’assistenza (QA).
Accoglienza del paziente
-Se il paziente non è intubato e non si prevede un'assistenza respiratoria in breve tempo, si
inizia la somministrazione di ossigeno con maschera o sondino naso-faringeo;
-Se invece necessita di essere intubato (in questo caso la situazione richiede
un’altra figura,un ausiliario o un altro infermiere) si procede immediatamente a
questa manovra: è importante, pertanto, avere già dei farmaci pronti (dobutrex,diprivan,atropina,adrenalina,norcuron,myotenlis,valium);
Si procede contemporaneamente al monitoraggio dei parametri emodinamici e
respiratori.
-saturazione arteriosa di O2;
-ecg;
-pressione arteriosa per via cruenta dopo incannulazione arteriosa, e si eseguono: emogasanalisi, elettrolit
ematicii ed osmolarità nel nostro
laboratorio; esami ematochimici e gruppo sanguigno presso il laboratorio
dell’ospedale;
-incannulazione vena centrale;
-posizionamento catetere vescicale;
-posizionamento sondino naso gastrico;
-igiene;
-rx torace;
-incontro con i parenti;
Intubazione endotracheale
L’intubazione endotracheale ha lo scopo di consentire una diretta connessione
tra le vie aeree del paziente e una miscela aria-ossigeno ad elevata percentuale
erogata attraverso un pallone o un respiratore meccanico.
In ambito
rianimatorio l’intubazione è un evento da eseguire in condizioni di emergenza o
di urgenza in pazienti critici: è quindi utile, prima di iniziare la manovra somministrare farmaci a
scopo sedativo e/o analgesico anche per ridurre gli effetti riflessi cardio-respiratori, che possono originare dall’importante innervazione sensitiva
di naso-faringe, oro-faringe e trachea. I farmaci più usati in questi casi sono:
-sedativo/ipnotici (benzodiazepine (valium),
-analgesici, meperidina (petidina),fentanile (fentanest);
-anestesici endovenosi,tiopentone sodico (farmotal) o propofol (diprivan).questi
farmaci possono essere anche associati.
- miorilassanti: suxametonio cloruro (myotenlis), Per ottenere un completo
rilassamento si ricorre anche al bromuro di vecuronio (norcuron). La posizione
del paziente dovrà essere tale da porre sullo stesso piano l’asse orale, faringeo
e laringeo, ciò si ottiene con la sopraelevazione e l’iperestensione della testa.
Criterio per il calcolo della misura dei tubi endotracheali
-
Per i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni si pratica la seguente
formula:
4+ (età in anni / 4),in questo caso si preparerà il tubo previsto e un tubo di
misura più piccola.
-
Età compresa tra 13 e 17 anni:femmine 7-7,5;maschi 7-7,5-8.
-
Età compresa tra 18 e 90 anni:femmine 7,5-8;maschi 8-8,5-9
Procedura per l’intubazione oro-tracheale.
-Si posiziona con la mano sinistra la lama del laringoscopio a livello della
radice dell’epiglottide, la manovra deve essere eseguita senza fare leva
sull’arcata dentaria superiore;
-Il tubo viene così introdotto con la mano destra nel cavo orale e fatto
procedere, sotto visione diretta, oltre le corde vocali, all’interno della
trachea;
-La cuffia del tubo a questo punto viene gonfiata e mediante l’ascoltazione del
torace ci si assicura che il tubo si trova in trachea. La complicanza più
frequente nell’intubazione oro-tracheale è l’avulsione dentale. Pur essendo una
procedura rapida e relativamente semplice, gli svantaggi, per i pazienti che
necessitano di intubazioni prolungate, sono diversi:
-instabilità del tubo;
-si annulla la funzionalità della deglutizione e quindi il paziente deve essere
alimentato soltanto dal sondino naso gastrico;
-riduce la possibilità di un accurata igiene orale;
-il paziente tende a mordere continuamente il tubo;
-aumenta la scialorrea;
La procedura dell’intubazione naso-tracheale è analoga a quella per l’intubazione
oro-tracheale, il tubo viene però fatto passare da una narice e posizionato con
l’aiuto della pinza di Magill. Questo tipo d’intubazione viene utilizzata quando
si prevede un periodo di ventilazione meccanica molto lungo. Gli svantaggi sono:
possibilità di epistassi e/o lesione del turbinato inferiore e la frequente
rottura della cuffia del tubo (avviene a livello del turbinato inferiore),che
costringe a sostituire il tubo immediatamente dopo il suo posizionamento. I
vantaggi sono:
-maggiore stabilità e quindi riduzione di rischi di estubazione anche in
pazienti molto irrequieti;
-manovre d’igiene del cavo orale più agevoli;
-non viene alterata la funzionalità della deglutizione e il paziente può essere
alimentato anche per via orale.
Saturimetria arteriosa di O2 (SaO2)
L’emogasanalisi fornisce un’informazione precisa ma temporanea sulla
situazione degli scambi gassosi a livello polmonare e, per superare questo limite
(evitando di fare emogasanalisi molto frequentemente) ci si affida ad un monitoraggio non
invasivo dell'ossigenazione, cioè quello della SaO2.
Mediante l’applicazione, più frequentemente a un dito della mano (ma è anche
possibile rilevare la saturazione arteriosa posizionandolo a un dito del piede o
ad un lobo dell’orecchio), di un sensore è possibile conoscere la percentuale di
emoglobina satura di ossigeno e visualizzare sul monitor l’onda pletismografica
(cioè l’equivalente del polso nei suoi aspetti specifici,altezza,ampiezza e
frequenza). Il principio di funzionamento di questo sensore si basa sulla
proprietà dell’emoglobina di assorbire specifiche lunghezze d’onde* luminose (la
rossa 660 nm e la quasi infrarossa, 940nm):la misurazione di una
parte, corrispondente alla pulsazione arteriosa,che attraversa e viene riflessa
dai tessuti e la sua elaborazione da parte dell’emoglobina forniscono i dati
richiesti.
Il sensore deve essere posizionato in modo tale che la sorgente luminosa rossa
poggi sull’unghia e la parte opposta (di metallo), che contiene il sensore vero
e proprio poggi sul polpastrello.
Alcune variabili possono condizionare la
lettura:
-mal posizionamento del sensore;
-Vasocostrizione periferica (comune in caso di grave ipotermia o shock,in questo
caso verranno rilevati valori più bassi di quelli reali).
-presenza di carbossiemoglobina COHB (quella legata al monossido di carbonio
responsabile d’intossicazioni dovute a malfunzionamento di stufe o caldaie, ma
presente anche nei grossi fumatori). In caso di intossicazione da monossido di
carbonio (CO) si otterranno valori di SaO2 elevati nonostante la quantità di
ossigeno presente in circolo sia ridotta in quanto il monossido di carbonio si
lega alla molecola di emoglobina come avviene per l’ossigeno ma in quantità
maggiore (circa 215 volte);
-unghie ispessite;
-smalto alle unghia che può cambiare lo spettro della luce riflessa;
E’ importante impostare al monitor dei limiti di allarme tali da poter
intervenire in tempo utile;
* le onde visibili sono quelle comprese tra i 380 e i 780 nm (manometri),cioè
tra il violetto e il rosso,passando per azzurro,verde, gialloverde (intorno ai
550 nm,dove la sensibilità dell’occhio umano è massima),giallo e arancio.Al di
sotto dei 380 nm si ha la luce ultravioletta e al di sopra dei 780nm quella
infrarossa
Valori di saturimetria
(%) |
Interpretazione |
| 97-100 |
Normale |
| 90-96 |
lieve ipossia,somministrare O2
|
| 85-90 |
ipossia grave,somministrare O2 ad alti flussi |
| < 85 |
Ipossia gravissima, rischio di arresto
cardiorespiratorio |
Elettrocardiogramma
Il monitoraggio continuo dell’elettrocardiogramma si attua applicando sul torace
(privo di peli per assicurarne l’adesione) 3 placche autoadesive dotate al
centro di una spugna conduttrice imbevuta di cloruro d’argento.La posizione
usuale delle placche è la seguente:
-una all’emiascellare sinistra all’altezza della linea mammillare (elettrodo
verde-massa);
-una sullo spazio tra la 3° e 4° (giallo-positivo) costola all’altezza dell’emiclaveare
sinistra;
-una controlaterale a destra (rosso-negativo).
La posizione delle placche può comunque variare secondo le necessità che si
presentano o che si possono prevedere:
-presenza di medicazione vena succlavia;
-possibilità di dovere defibbrillare il paziente.
Alle placche si collegano gli elettrodi che confluiscono al monitor in un unico
cavo. Quindi bisogna regolare ampiezza e derivazione in modo tale da poter avere
una traccia senza artefatti (l’allarme più frequente l’asistolia è dato dalla
mancata lettura del complesso QRS, in questo caso bisogna aumentare l’ampiezza
dell’onda). I limiti di allarme devono essere regolati in base alla situazione
emodinamica del paziente.Quando la traccia è irregolare ciò può essere dovuto o
a mal posizionamento delle placche o a brividi del paziente, e bisogna
intervenire o riposizionando le placche o riscaldando il paziente.
Cateterismo arterioso
Nel nostro reparto a tutti i pazienti viene incannulata un’arteria, ciò consente:
-di non ricorrere alla puntura dell’arteria ogni qualvolta se ne presenta la
necessità (spesso anche 10 volte al giorno), tecnica lesiva a lungo termine per
le arterie e fastidiosa per il paziente;
-un monitoraggio continuo della pressione arteriosa che ci permette di valutare
efficacia od eventuali effetti collaterali di farmaci che agiscono sul sistema
cardiovascolare;
-di eseguire prelievi ematici sia per normali esami ematochimici che per il
controllo emogasanalitico.
Prima di procedere alla puntura si dovrà:
-informare il paziente quando è possibile;
-procedere alla rimozione dei peli (femorale);
-posizionare il paziente a seconda dell’arteria da incannulare.
Vie d’accesso
L’arteria radiale di solito è la più facile da reperire. Essa è un ramo
terminale dell’arteria brachiale e, grazie alle anastomosi con l’arteria ulnare
costituisce gli archi palmari profondo e superficiale,garantendo la
vascolarizzazione della mano.
Per la incannulazione dell’arteria radiale usiamo un catetere Venflon 20G (32 mm)
per gli adulti e 22G (25mm) per i bambini.Per incannulare l’arteria radiale
bisogna posizionare il polso in iperestensione in modo tale da ottenere una
maggiore superficializzazione del vaso, per ottenere questo risultato di solito
si posizione un rotolo sotto il polso.
E’ preferibile,soprattutto quando il paziente è irrequieto, procedere
all’esecuzione di questa manovra in due operatori per evitare di perdere
l’accesso. Uno dei due operatori dovrà tenere il palmo della mano e l’avambraccio
del paziente evitando di iperestendere troppo il polso. Una volta palpata
l’arteria con l’indice e il medio, può essere cannulata facendo in modo che il
catetere formi un angolo di circa 30° con la cute. Appena si nota il reflusso di
sangue,si avanza all’interno del vaso di 4-5 mm il catetere e nello stesso tempo
si tira all’esterno in egual misura l’anima del catetere.
Arteria femorale
Nel nostro reparto l’accesso arterioso viene scelto come ultima possibilità
quando nel paziente non sono più palpabili altri polsi arteriosi, perché questo
approccio è gravato dal rischio di infezione dal catetere vescicole; questo
inconveniente viene controllato dalla correttezza delle procedure di nursing.
L’arteria femorale origina dall’iliaca esterna ed è facilmente reperibile al di
sotto del legamento inguinale decorrendo lateralmente alla vena femorale nel
triangolo di scarpa..Il suo ampio diametro consente di posizionare cateteri di
dimensioni più grandi ed inoltre l’elevato rapporto “diametro vasale/diametro
del catetere” riduce il rischio di complicanze trombotiche e ischemiche.
La procedura di incannulazione femorale prevede:
- l’iperestensione della coscia sul bacino, con extrarotazione della stessa per
superficializzare il vaso;
- La palpazione dell’arteria al di sotto del legamento inguinale e la sua
cannulazione;
Per la cannulazione dell’arteria nel nostro reparto utilizziamo due tecniche:
quella dell’ago cannula (venflon) e quella secondo Seldinger. Quest’ultima
tecnica viene usata quando si devono adoperare per la incannulazione dell’arteria
cateteri più lungi dei venflon, quindi dai 6 cm in sù.
-La puntura dell’arteria avviene con un ago metallico,non appena si nota il
reflusso di sangue si toglie la siringa o il tappo dal cono dell’ago e si fa
scorrere al suo interno una guida metallica (compresa nel set) posizionandola
per alcuni cm all’interno dell’arteria;
- L’ago viene rimosso (lasciando in situ la guida metallica);
- A questo punto si fa scorrere il catetere lungo la guida ed una volta
posizionato questa si deve togliere.
Collegamento dell’accesso arterioso al sistema di monitoraggio e di lavaggio
Una volta incannulata l’arteria, bisogna collegare al catetere un sistema di
lavaggio e monitoraggio pressorio.
Il sistema è formato da:
-una via che connette il catetere arterioso al trasduttore;
-una via di lavaggio continuo del catetere arterioso;
-una via di connessione dal trasduttore al monitor;
Le prime due sezioni del sistema si possono considerare idrauliche in quanto
riempite di liquido ( la prima di esse è destinata a trasportare passivamente al
trasduttore gli impulsi sfigmici captati dal catetere), la terza è di fatto
elettronica ed è fondamentale per visualizzare al monitor l’onda pressoria ed i
valori.
Nel nostro reparto per il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa
utilizziamo un circuito già pronto in commercio completo anche di deflussore da
connettere alla sacca di soluzione fisiologica e non viene quindi assemblato da
noi come avveniva fino a pochi anni fa.
Nel circuito si osserva:
- il trasduttore con il proprio dispositivo di lavaggio continuo (intraflo II)
che consente alla soluzione fisiologica di fluire lungo il sistema alla velocità
di 3 ml/h);
-un rubinetto a tre vie in posizione prossimale, necessario per poter fare lo
“zero” senza il quale il monitor non inizia a rilevare i valori pressori. Lo
zero è una calibrazione, per ottenerla bisogna posizionare il trasduttore
all’altezza dell’atrio, aprire all’aria il trasduttore chiudendo nello stesso
tempo la via arteriosa e seguire le indicazioni che si visualizzano al monitor. Al
contrario di altri monitoraggi (ECG,SaO2,per i quali elettrodi e sensore si
possono variare di posizione) per la pressione arteriosa il trasduttore deve
rimanere sempre all’altezza dell’atrio,altrimenti si avranno valori
falsi:elevati se si trova al di sotto, bassi se si trova al di sopra;
-un rubinetto a tre vie in posizione distale da collegare al catetere e dal
quale vengono eseguiti i prelievi ematici per la determinazione dell’EAB.
Dopo aver collegato al sistema di lavaggio la sacca di soluzione
fisiologica,questa deve essere inserita all’interno di una sacca
pressurizzatrice mantenendo costantemente una pressione di 300 mmHg. Ciò
consente di mantenere la pervietà dei vari elementi (senza bisogno di mettere
eparina all’interno della sacca di fisiologica),evitando la formazione di
coaguli o il reflusso accidentale di sangue dall’arteria, permettendo il
lavaggio rapido ogni qualvolta la cannula arteriosa viene utilizzata a fini di
prelievo senza modificarne al traduzione del segnale.
Anche per il monitoraggio della pressione arteriosa è necessario impostare gli
allarmi in base condizioni emodinamiche del paziente;
I criteri di scelta dell’arteria da incannulare sono i seguenti:
-diametro sufficiente;
-buona circolazione collaterale;
-facilità nelle manovre di nursing;
-basso rischio infettivo.
Arteria diametro (Gauge) lunghezza (cm)
Radiale 20 3-6
Femorale 18-20 10-20
Pedidia 20 3-6
Brachiale 18 3-6
Cateterismo venoso centrale
Il posizionamento di un catetere venoso centrale nel nostro reparto è una
procedura comune,esso viene posizionato infatti a tutti i pazienti. Ciò permette
di infondere farmaci di varia natura anche ad elevata velocità di flusso o in
modo controllato,farmaci estremamente attivi nel sistema cardiovascolare.Non
viene utilizzato per monitorare la pressione venosa centrale (PVC) un valore per
noi di scarsa rilevanza superato da altri parametri.Si definisce catetere venoso
centrale perché il suo estremo terminale si va a posizionare in prossimità dello
sbocco nell’atrio destro di una delle grandi vene intratoraciche, la cava
superiore o la cava inferiore.Il catetere può essere posizionato attraverso due
tipi di accesso venoso:superficiale,quando decorre a livello soprafasciale ed è
visibile o palpabile,e sono la vena basilica,cefalica e la giugulare
esterna;profondo,quando decorre a livello sottofasciale e non sono visibili né
palpabili e solitamente presentano un calibro maggiore rispetto alle
superficiali,e sono la vena succlavia,giugulare interna e la femorale. Il
catetere dovrà essere sufficientemente lungo:15-20 cm nella incannulazione della
vena succlavia o giugulare esterna,40-50 cm per la femorale,70 cm per la
basilica o cefalica.Il posizionamento di catetere a più lumi (2-3) consente di
utilizzare un solo accesso venoso per realizzare infusioni diversificate,in vie
distinte.Un catetere a più lumi presenta un orifizio prossimale,uno mediale e
uno distale,le dimensioni in queste cannule sono tra i 16 e i 18 G.
Prima di procedere alla puntura si dovrà:
-informare il paziente quando è possibile;
-procedere alla rimozione dei peli (succlavia, femorale);
-spostare le placche dell’ECG (succlavia);
-posizionare il paziente a seconda dell’area destinata alla venipuntura.
Posizionamento del
paziente in base all’accesso da incannulare:
Vena succlavia:paziente supino in leggero trendelemburg,braccia lungo il
corpo,un rotolo sotto le spalle,testa ruotata,dal lato opposto a quella in cui
si opera;
Vena giugulare esterna:paziente supino,in leggero trendelemburg,braccia lungo il
corpo,un rotolo al di sotto delle spalle,testa iperestesa e ruotata dal lato
opposto a quello in cui si opera;
Vena basilica e cefalica,sono facilmente cannulabili (ma con cateteri ad 1 lume
16G,70 cm per poter arrivare allo sbocco della cava superiore) alla piega del
gomito,dove scorrono superficialmente e visibili dopo posizionamento del laccio
emostatico.Per fare avanzare il catetere al suo interno è necessario estendere
l’arto abducendolo.
Gli inconvenienti sono:impossibilità di poter posizionare un catetere a più lumi,e
spesso è necessario immobilizzare l’arto del paziente che tende a piegarlo.
Vena femorale:paziente supino,arto inferiore abdotto ed extraruotato, sollevare
il pannicolo adiposo addominale (se necessario),proteggere la regione pubica.
La incannulazione viene eseguita dal medico,ma è importante il ruolo
dell’infermiere che deve assisterlo in vari modi durante la procedura:predispone
e fornisce al medico il materiale necessario,trattiene la testa o l’arto del
paziente nel caso un alterato stato di coscienza provochi agitazione nel
paziente stesso,verifica al monitor eventuali alterazioni del ritmo cardiaco.
In caso di incannulamento di un accesso cavale superiore bisogna richiedere un
controllo radiologico del torace sia per valutare la posizione del catetere sia
per evidenziare complicanze iatrogene.
Catetere diametro (Gauge) lunghezza (cm)
Anche per l'incannulazione venosa centrale vengono usate due tecniche:La tecnica
dell’ago-cannula viene soltanto usata per la incannulazione della vena basilica o
cefalica (cateteri da 70cm).
La tecnica di Seldinger viene utilizzata per incannulare tutti gli altri accessi.
Catetere vescicale
A tutti i nostri pazienti viene posizionato un catetere vescicale. Se il
paziente ha già avuto posizionato il catetere vescicale da poche ore (in altro
reparto,sala operatoria o al pronto soccorso) evitiamo di sostituirlo. Il
monitoraggio della diuresi ci dà indicazioni sia di tipo qualitativo che
quantitativo.Il posizionamento di un catetere vescicale e il suo mantenimento
costituiscono uno degli aspetti qualificanti dell’attività assistenziale in
un’area critica,le procedure non sono prive di rischi o di aspetti collaterali
negativi (le infezioni correlate al catetere vescicale rappresentano una
complicanza frequente del cateterismo vescicale. Noi usiamo cateteri in
silicone,materiale che consente la permanenza in situ (rispetto ad altro
materiale) per lunghi periodi,15-20gg. Questi cateteri sono dotati di
termistore,un sistema elettronico per la determinazione della temperatura,il suo
uso consente di trasformare il segnale termico in impulso elettrico,amplificarlo
ed evidenziarlo al monitor.
Sondino naso gastrico
Nel nostro reparto il sondino naso gastrico viene posizionato a tutti i
pazienti,lo scopo è quello di svuotare lo stomaco da accumulo di aria o da
eventuale ristagno,ma soprattutto viene usato per alimentare il paziente,infatti
l’alimentazione entrale rappresenta un supporto a quella parenterale e,viene
iniziata entro le 24 ore dal ricovero perché svolge azione protettiva nei
confronti della mucosa gastrointestinale dove in condizioni di digiuno
prolungato è facile l’insorgenza di emorragie e ulcere da stress.Le sonde da noi
usate sono di due tipi e a doppia via:Salem,in PVC (14-16-18 F),Flexiflo in
poliuretano biocompatibile (da 14 F) quest’ultima viene posizionata quando
si prevede un periodo di alimentazione entrale lungo.La sonda viene posizionata
in sede intragastrica,va lubrificata ed introdotta da una narice con direzione
sagittale lungo la parete delle coane per raggiungere il faringe e fatta
proseguire nell’esofago.Nel paziente comatoso bisogna flettere leggermente la
testa in avanti per facilitare il passaggio della sonda in esofago,in caso di
arrotolamento nell’oro-faringe si dirige la stessa in esofago sotto visione
diretta in laringoscopia con la pinza di magill e si controlla ugualmente il
corretto posizionamento:insufflare 30-50 ml di aria con una siringa cono
catetere e,ascoltando con il fonendoscopio nella regione epigastrica si deve
percepire il gorgoglio provocato dal passaggio dell’aria. Questo controllo và
fatto sempre prima di somministrare qualsiasi alimento. (Non eseguire mai questo
controllo insufflando acqua)
Igiene
Viene eseguito a tutti i pazienti (tranne quelli provenienti dalla sala
operatoria).
In caso di accoglienza di un paziente intossicato da esteri organo-fosforici* è
necessario munirsi di mascherina,e l’igiene è più accurato compreso lo shampoo;
*Questi composti sono presenti in insetticidi ed erbicidi,la penetrazione
nell’organismo (inalatoria,orale,cutanea) avviene a scopo suicida o quando non
vengono prese le necessarie precauzioni,e spesso coinvolge anche i soccorritori.
Radiografia del torace
Viene eseguita sempre all’ingresso e per verificare dopo la cannulazione di vena
succlavia o giugulare sia l’esatto posizionamento che un eventuale pneumotorace.
Elettrocardiogramma
Viene eseguito a tutti i pazienti,tranne quelli provenienti da:sala operatoria o
dal pronto soccorso (se è stato eseguito).
Incontro con i parenti
Dopo che il paziente viene portato nel suo posto letto è necessario incontrare i
parenti (medico ed infermiere) sia per informarli delle condizioni cliniche che
per la raccolta di notizie relative ad anamnesi patologica, farmacologia e per
la compilazione cartella infermieristica
Informazioni sulla rivista
ESIA-Italia
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and CRITICAL CARE MEDICINE - Italia
costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet
da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori
saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua
Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,
qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo. A cura della redazione sarà
inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese. La
rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta,
inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione
italiana" indirizzato a LANZA@UNIPA.IT
La rivista pubblica rewiews e lavori originali
compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali
riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici.
Le reviews includono argomenti per l'Educazione Medica Continua (EMC), articoli
di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le
lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed
anche brevi comunicazioni. La guida per gli autori può essere consultata
collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo: http://anestit.unipa.it/
utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia; oppure
può essere richiesta inviando un messaggio a lanza@unipa.it
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and
CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana
Il numero della rivista è anche ottenibile
attraverso World-WideWeb WWW: l'URL per questo numero di ESIA è:
http://anestit.unipa.it/esiait/esit200310.txt
Il nome della rivista è esitaaaamm, dove aaaa è l'anno
ed mm il mese (per esempio questo numero è esit200310.txt)
LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA
DIRETTORE: Vincenzo LANZA
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli Palermo LANZA@UNIPA.IT
Terapia Intensiva
Antonio Braschi
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1 - Policlinico S. Matteo -
IRCCS Pavia
Anestesia Cardiovascolare
Riccardo Campodonico
Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica - Azienda
Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it
Anestesia e malattie
epatiche
Andrea De Gasperi
Gruppo trapianti epatici / CCM - Ospedale Niguarda - Milano
Medicina critica e
dell'emergenza
Antonio Gullo
Professore di Terapia Intensiva - Direttore del Dipartimento di Anestesia e
Terapia Intensiva -Università di Trieste
Anestesia ed informatica
Vincenzo Lanza
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione - Ospedale Buccheri La
Ferla Fatebenefratelli - Palermo
Tossicologia
Carlo Locatelli
Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di
Pavia - Fondazione Scientifica "Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e
della Riabilitazione"- Pavia
Terapia Antalgica e Cure
Palliative
Sebastiano Mercadante
Responsabile dell' Unità d'Anestesia e di Terapia del Dolore e Cure
Palliative - Dipartimento Oncologico La Maddalena - Palermo terapiadeldolore@la-maddalena.it