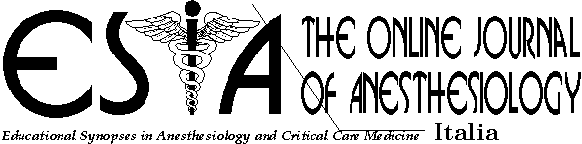
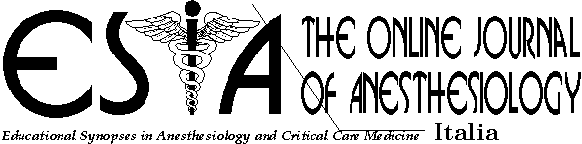
ISSN 1080-3521
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -
|
|
Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line può essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine | |
In questo numero:
1 LA FOSSA CARDIACA
2 LA DOBUTAMINA NELL'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IPOSSIEMICO-IPERCAPNICA DEI PAZIENTI CON BPCO. ESPERIENZA CLINICA
3 L'INTOSSICAZIONE DEL MESE: TENTATO SUICIDIO PER INGESTIONE DI CLOZAPINA
4 MANUALI DI ANESTESIA:LAMINECTOMIA PER ERNIA DISCALE
________________________________________________________
1 LA FOSSA CARDIACA
________________________________________________________
Piergiuseppe Agostoni,Gaia Cattadori
Istituto di Cardiologia, Centro Cardiologico - Fondazione "Monzino",
Istituto di Ricerche Cardiovascolari
del CNR, IRCCS, Università di Milano
La valutazione della funzione ventricolare è stata fatta, fin dai tempi di Starling, per ognuno dei due ventricoli in termini di relazione tra pressione e volume o di parametri da essi derivati. Infatti nel preparato cuore-polmone di Starling, di cui in figura 1 è riprodotto il modello, è possibile regolare il precarico agendo sul riempimento (1,2 = regolazione del contenitore 3 che regola il contenitore del sangue), misurare la pressione (4) ed i volumi del cuore (5) e la pressione in aorta (6).
| Questa concezione è del tutto corretta per la singola fibra miocardica e per il ventricolo isolato, ma non lo è per il cuore in toto. La coscienza di questo è di almeno 20 anni fa ed ha portato all'introduzione del concetto di interdipendenza ventricolare mediata dal setto e da forze di costrizione extramiocardiche, il cui equivalente anatomico è stato riconosciuto nel pericardio. In effetti, esperimenti classici quali quelli che si trovano su tutti i libri di terto di Weber e Janicki, hanno dimostrato che il volume di riempimento di un ventricolo influenza la relazione pressione/volume dell'altro e che tale influenza è notevolmente aumentata se è presente il pericardio (figura 2). Questi esperimenti hanno fatto si che il pericardio fosse considerato come la determinante della interdipendenza interventricolare. | fig.1 |
Queste evidenze sperimentali sono state estrapolate alla clinica; per esempio, è stato identificato nel "costraint" pericardico la causa di frequenti alterazioni del riempimento dei due ventricoli con inversione del rapporto temporale riempimento proto/tele diastolico. Similmente, il pericardio è stato considerato il responsabile dell' aumento 1 a 1 della pressione atriale destra e della pressione di cuneo polmonare nei pazienti con le forme più avanzate di scompenso cardiaco (nei soggetti normali, o nelle forme iniziali della malattia o a carichi di lavoro modesti l' incremento durante esercizio della pressione di cuneo polmonare è circa il triplo di quello della pressione atriale destra).
Fig.2
 | 
|
 | 
|
Tutte queste osservazioni sono singolarmente
corrette; risulta tuttavia azzardato avvalorare la dipendenza
logica dell' una dall' altra. Infatti, il cuore è si' avvolto
dal pericardio, ma è sito in uno spazio ben determinato
circondato dai polmoni, dal diaframma e dallo sterno. Inoltre,
il rapporto meccanico tra cuore ed organi che lo circondano è
mediato dalle sierose che li attorniano, pleure e pericardio,
che sono separate tra loro da uno spazio virtuale privo di punti
fissi di applicazione di forza (di contatto) e che devono scivolare
l'una sull'altra permettendo, al minor costo energetico possibile,
i movimenti del cuore e dei polmoni. Non c'è, in altre
parole, uno spazio vuoto attorno al pericardio ma una serie di
strutture indipendenti con la loro resistenza elastica e/o viscosa
e con le loro forze di adesione di superficie.
Proprio per questo, autori anglosassoni
hanno coniato ed utilizzato il termine di "fossa cardiaca"
intendendo così descrivere la cavità dove si trova
il cuore o, per dire come loro, dove il cuore è annidato.
La meccanica della fossa cardiaca può essere favorevole
o non favorevole per la rivoluzione cardiaca, al punto che John
Butler, "il padre spirituale" del concetto di fossa
cardiaca, ad un primo editoriale "the heart is in good hands",
ha fatto seguire un secondo "the heart is not always in good
hands", dove le mani attorno al cuore rappresentano la fossa
cardiaca.
Anche il torace, di per se, è in grado di generare una
portata anterograda indipendente dall' attività cardiaca.
Un esempio clinico è il massaggio cardiaco ed uno fisiologico
è la tosse. Quest' ultima (figura 3) si associa ad aumento
della pressione intratoracica con movimento di sangue verso le
regioni extratoraciche; tale flusso è però solo
arterioso perchè la collasibilità delle vene fa
si che con l' inizio del flusso del sangue si instauri un gradiente
transparietale venoso che porta alla chiusura delle vene nel punto
di passaggio tra intra ed extra torace. Nella figura 4 è
riportato l' effetto della tosse (frecce) sulle pressioni intravascolari
intratoraciche (atrio destro ed arteria polmonare) ed extravascolari
(arteria sistemica). In caso di fibrillazione ventricolare la
tosse ritmica è in grado di prolungare lo stato di coscienza
del soggetto.
| fig.3 | fig.4 |
L' errore iniziale dei cardiologi è stato quello di estrapolare dati sperimentali ottenuti sul cuore, più o meno avvolto dal pericardio, all'intero torace, dove c'è molto oltre al pericardio. Ma, se è chiaro che le caratteristiche fisiche (di pressione e volume) del polmone influenzano la circolazione nei vasi polmonari, è meno apprezzato se esista una qualche evidenza clinica del ruolo della fossa cardiaca nel determinare la meccanica del cuore. In realtà queste evidenze sono numerose ma difficili da integrare fra loro:
a) L'ipertrofia della parete libera del ventricolo sinistro riscontrata all'esame autoptico in pazienti con bronchite cronica privi di malattia coronarica o ipertensione. Una causa verosimile di questo riscontro è l'aumento del lavoro esterno del cuore contro un polmone più rigido.
b) Il miglioramento, dopo riduzione chirurgica del volume del polmone, in alcuni tipi di enfisema, della performance cardiorespiratoria durante esercizio.
c) L'osservazione che parametri ventilatori registrati all'apice dell'esercizio, quali volume corrente, rapporto ventilazione per spazio morto / ventilazione corrente e compliance dinamica del polmone correlano con la capacità di esercizio nei pazienti con scompenso cardiaco. La ragione di questo, oltre all' azione sul circolo polmonare, potrebbe essere un effetto meccanico diretto del polmone rigido sul cuore. Corollario di tale osservazione è il riscontro nei pazienti con scompenso cardiaco di aumento del lavoro dei muscoli respiratori e la comparsa in essi, del fenomeno della fatica muscolare.
d) Il riscontro sperimentale che l'applicazione di pressione tele-espiratoria positiva riduce la portata cardiaca anche quando il riempimento dei ventricoli è artificialmente mantenuto. Questa riduzione di portata è dovuta a "costraint" extrapericardico.
e) L' osservazione che la mancata richiusura del pericardio al termine di intervento cardiochirurgico non ha apprezzabili consequenze.
f) Il variare della meccanica cardiaca all' apertura dello sterno (a pericardio ancora intatto) a dimostrazione che la medesima è influenzata dal torace. Il fatto che la successiva apertura del pericardio a sua volta influenzi la meccanica cardiaca non riveste sicura importanza in quanto le condizioni di osservazione non sono più fisiologiche essendo già aperta la cavità toracica.
g) Il riscontro che l'ultrafiltrazione plasmatica, metodica che permette di aumentare la capacità di esercizio dei pazienti con scompenso cardiaco moderato agendo sulle caratteristiche fisiche del polmone (riduzione del suo contenuto idrico), migliora i parametri ventilatori a riposo e durante esercizio (figure 5 e 6) e ripristina, in assenza di variazione dei volumi del cuore, un normale rapporto tra riempimento proto e tele diastolico in entrambi i ventricoli. La sottrazione di acqua plasmatica inoltre modifica in tali soggetti il rapporto di incremento tra pressione atriale destra e wedge da 1 a 1 a 1 a 3 essendo la prima considerata, lo ricordo, segno di "costraint" pericardico; ma la manovra di ultrafiltrazione non agisce sul pericardio o sui volumi del cuore, bensì sul polmone, che è il determinante principale della meccanica della fossa cardiaca.
  
| fig.5 |
 
| fig.6
+ =pericardio integro - =pericardio aperto PRV=Pressione telediastolica ventricolo dx LRV=Pressione telediastolica ventricolo sn VRV=Volume telediastolico ventricolo dx VLV=Volume telediastolico ventricolo sn |
In conclusione l'impressione è
che l'ambiente in cui il cuore si trova fortemente influenzi la
sua meccanica. Questa influenza ha tardato ad essere apprezzata,
perchè spesso in clinica si applicano nozioni ottenute
in laboratorio senza considerare che la sineddoche può
essere arbitraria e può fuorviare generazioni di cardiologi.
Letture consigliate:
___________________________________________________________________
2 LA DOBUTAMINA NELL'INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA ACUTA IPOSSIEMICO-IPERCAPNICA DEI PAZIENTI CON BPCO.
ESPERIENZA CLINICA
___________________________________________________________________
E. VIRONE
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA Azienda Ospedaliera
"S. Elia". Caltanissetta
SUMMARY:
The respiratory failure is the most frequent admission motive
for chronic obstructive pulmonary disease patients. The use of
conservative - semintensive and medical treatment ( using procedures
of mechanical non invasive ventilation and integrated-pharmacological
approach) reduces the admission of patients in the resuscitation
centers, in which, moreover, the invasive procedures join to elevated
mortality. The inotropic support with Dobutamine treatment causes
a significant recovery of gaseous exchanges ( evaluation of haemodinamic
parameters), which are very important for a valid transport and
use of oxygen in periphery, with consequent improvement of haematosis
and arterial saturation.
Key word:
Respiratory failure. Dobutamine. BiPAP. Haemodinamic parameters.
RIASSUNTO:
L'Insufficienza Respiratoria rappresenta la causa più frequente
di ricovero dei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Il ricorso alla terapia medica conservativa a carattere semi-intensivo,
con tecniche di ventilazione meccanica non invasiva e di un adeguato
approccio farmacologico integrato, consente la riduzione dei ricoveri
di tali pazienti nei centri di rianimazione, dove peraltro le
tecniche invasive si associano ad elevata mortalità. Il
sostegno inotropo ottenuto dall'impiego della Dobutamina permette
un significativo recupero degli scambi gassosi a motivo dell'ottimizzazione
dei parametri emodinamici, che sono di fondamentale importanza
per garantire un efficace trasporto e utilizzazione dell'ossigeno
in periferia, con conseguente miglioramento dell'ematosi e della
saturazione arteriosa.
Parole chiave:
Insufficienza Respiratoria. Dobutamina. BiPAP. Indici Emodinamici.
L'Insufficienza Respiratoria (I.R.) ipossiemica e/o ipossiemico - ipercapnica costituisce la causa più frequente di ricovero ospedaliero dei pazienti con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. La valutazione dei parametri clinico-strumentali in corso di riacutizzazione, e dei relativi tempi di ricovero, ha consentito di evidenziare come la terapia medica conservativa, a carattere semi-intensivo (1), permetta il rapido recupero clinico-funzionale di tali pazienti, evitandone spesso il ricovero in terapia intensiva, dove tra l'altro il ricorso a manovre invasive non migliora la prognosi a lungo termine (2).
Scopo del presente lavoro è quello di verificare l'efficacia della Dobutamina in terapia semi-intensiva nel migliorare gli scambi gassosi, nel sostenere e ridurre il lavoro del cuore (3) e nel limitare i tempi di ventilazione meccanica non invasiva dei pazienti respiratori critici, evitandone quindi il trasferimento in Rianimazione.
La Dobutamina (Dobutrex; Lilly) è
un farmaco inotropo positivo, non digitalico, ad effetto alfa1,
beta1 e beta2 recettoriale,con emivita plasmatica di due minuti,
che non possiede l'effetto tiramine-like della Dopamina e che
consente un'azione bilanciata, con netta prevalenza dilatatrice,
sulle resistenze arteriolari sistemiche e polmonari; non aumenta
il consumo di ossigeno del miocardio per una azione di rilasciamento
isovolumetrico in fase diastolica. Il suo effetto cronotropo e
batmotropo positivo è minore rispetto a quello della Dopamina
e in corso ipossiemia non ha gli svantaggi dell'impiego della
Digitale.
Abbiamo studiato un primo gruppo di
dieci pazienti di entrambi i sessi di età compresa tra
50 e 80 anni con storia di broncopatia cronica ostruttiva che
giungevano in reparto con grave ipossiemia e\o ipossiemia - ipercapnia
con quadro di severa acidosi respiratoria scompensata. Sono stati
esclusi dallo studio i pazienti con anamnesi positiva per cardiopatia
ischemica,miocardiopatia dilatativa,valvulopatie e turbe maggiori
del ritmo. I pazienti, previo incannulamento venoso periferico,
sono stati trattati all'ingresso con infusione venosa di Dobutamina
a dosaggio di 10 mcg\kg\min, Teofillina (5 mg\kg) e Furosemide
(20-60 mg).
La terapia antibiotica è stata assicurata dall'associazione
di beta lattamici con aminoglicosidi. E' stato sempre garantito
il bilancio idro-elettrolitico e l'apporto nutrizionale è
stato fornito da adeguato apporto calorico (60% lipidi - 40% carboidrati
ed AA essenziali). E' stato selezionato altresì un secondo
gruppo di pazienti con sovrapponibili caratteristiche cliniche
e gasanalitiche del primo che riceveva lo stesso protocollo terapeutico
ad eccezione della Dobutamina che veniva sostituita da Digossina
a dosaggio di 0.125-0,25 mg\die.(Tabella I).
L'assistenza respiratoria veniva assicurata ad entrambi i gruppi
da ossigenoterapia controllata e quando necessario da ventilazione
meccanica in modalità BiPAP con interfaccia nasale su ciclo
assistito\controllato con FiO2 > 24 % per tempi medi giornalieri
di nove ore (Tabella II).
| GRUPPO | Età | N. | Sex | pH | PaCO2 | PaO2 | PaO2\FiO2 |
| 1
(Dobutamina) 10mcg\kg\min | 50-60 | 2 | m | 7,27 +\ - 0.05 | 70 +\ -15 | 48 +\ - 7 | 228 +\ -33 |
| 60-70 | 3 | f | 7,23 +\ - 0.04 | 72 +\ -15 | 50 +\ - 5 | 238 +\ -23 | |
| 70-80 | 5 | m | 7,25 + \ - 0.05 | 75 +\ - 10 | 45 +\ - 8 | 252 + \ - 38 | |
| 2
(Digossina) 0,125- 0,25 mg | 50-60 | 3 | m | 7,28 +\ - 0.05 | 71 +\ - 18 | 48 +\ - 6 | 228+\-30 |
| 60-70 | 2 | f | 7,24+\ - 0.03 | 68 +\ - 15 | 52 +\ - 4 | 247+\-19 | |
| 70-80 | 5 | m | 7,25 +\ - 0.05 | 73 +\ - 10 | 47 +\ - 6 | 223+\-38 |
| GRUPPO | Pz | Ore\die | IPAP | EPAP | FiO2 |
| 1 | 7 | 7-11 | 12-20 | 2-4 | 28-35 % |
| 2 | 8 | 7-11 | 12-20 | 2-4 | 28-35 % |
La radiografia del torace mostrava all'ingresso, nel 50 % dei casi, impegno parenchimale di tipo acino - alveolare o interstiziale che giustificava il motivo della riacutizzazione
Abbiamo monitorizzato in continuo ECG,PAO,SpO2,PtCO2.
Il prelievo arterioso per la valutazione dell'equilibrio acido-base
veniva effettuato ogni quattro ore. E' stata altresì valutata
la pressione polmonare in eco-doppler.
Nei pazienti del primo gruppo, in ogni fascia di età esaminata, abbiamo rilevato un progressivo, rapido e stabile miglioramento degli scambi gassosi, soprattutto dei parametri ossigeno-derivati, con riduzione nel tempo dei cilci di ventilazione meccanica non invasiva. Le pressioni polmonari si sono ridotte più rapidamente ed efficacemente nei pazienti in trattamento con Dobutamina rispetto ai controlli trattati con Digitale. In nessun caso dei pazienti del primo gruppo è stato necessario il ricovero in Terapia Intensiva (T.I.), mentre tre pazienti in trattamento con Digossina hanno richiesto il trasferimento per assistenza respiratoria con intubazione endotracheale. L'infusione di Dobutamina, ai dosaggi indicati, non ha mai provocato significative modificazioni della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa media , nè indotto turbe del ritmo. La SaO2 si è corretta in modo più rapido e stabile nei pazienti del primo gruppo; mentre nei pazienti in trattamento con Digossina abbiamo notato il prolungamento dei tempi di ventilazione meccanica, senza peraltro raggiungere in modo costante i parametri ottimali di ossigenazione.(Tabella III: analisi descrittiva dei dati espressa mediante la media +\ - deviazione standard dei singoli parametri).
Inoltre nei pazienti in trattamento
con Dobutamina abbiamo osservato la progressiva tendenza al miglioramento
dell'ematosi e dei relativi parametri gasanalitici, rilevati in
aria ambiente, già dopo due giorni di assistenza respiratoria
meccanica (Tabella IV); un ulteriore recupero degli scambi gassosi
si otteneva mediamente in quinta giornata con la relativa stabilizzazione
clinica dei pazienti, permettendo la sospensione del supporto
ventilatorio fino alle dimissioni, che in alcuni casi avvenivano
con prescrizione di OTLT se ne ricorrevano le indicazioni. La
degenza media è stata di 10 gg. per i pazienti del primo
gruppo contro i 20 gg. del secondo gruppo.
| GRUPPO | gg\ BiPaP | h\die BiPaP | T.I. | PaO2 | SaO2 | pH | PaCO2 | PAP |
| 1 | 4- 7 | 4- 6 | --- | 80+\ - 5 | 96 +\-2 | 7,37
+\- 0.02 | 48+\ -5 | 28+\ - 3 |
| 2 | 7-10 | 7- 11 | 3 | 65 +\ -9 | 91 +\ - 3 | 7,33
+\ - 0.03 | 52+\- 6 | 34+\ - 2 |
| GRUPPO | pH | PaCO2 | PaO2 | SaO2 | PaO2\FiO2 |
| 1 | 7,34 +\ - O.O3 | 55+\ -4 | 62+\-7 | 92+\-2 | 295+\ -33 |
| 2 | 7,30 +\ - O,O2 | 61+\-3 | 56+\-3 | 89+\-3 | 266+\ -12 |
L'esperienza clinica condotta ci porta a considerare come nei pazienti con I.R. il principale fattore prognostico favorevole sia l'incremento dell'indice cardiaco che assicura un efficace compenso emodinamico all'ipossiemia e una adeguata disponibilità di ossigeno in periferia (3). Infatti l'ossigenazione tessutale è garantita sia dall' efficacia del contenuto arterioso in ossigeno (CaO2) sia dalla validità dell'Indice Cardiaco ( I.C.) : tali parametri insieme determinano ed assicurano la disponibilità di ossigeno ai tessuti ( DO2= CaO2 x I.C.) (4) . Nei pazienti con BPCO ed I.R., la severa diminuzione del CaO2 viene principalmente compensata dall'incremento della gettata cardiaca, essendo poco efficaci gli altri meccanismi di compenso: vasocostrizione polmonare ipossica, policitemia e spostamento a destra della curva di dissociazione dell'emoglobina (3,5). Tuttavia, nei pazienti BPCO le sezioni destre del cuore sono sottoposte ad un incremento del carico di lavoro per aumento dell'impedenza arteriolare polmonare su base ipossica, a cui segue ipertrofia ventricolare destra che tende a generare scompenso emodinamico con compromissione sequenziale delle sezioni sinistre e della gettata cardiaca: la funzione del ventricolo sinistro viene principalmente compromessa in fase diastolica per spostamento del setto interventricolare e riduzione della compliance (interdipendenza ventricolare). In queste situazioni il compenso alla riduzione del CaO2 viene affidato principalmente all'estrazione periferica di ossigeno che risulta nettamente aumentata (6) al fine di mantenere costante il consumo di O2 (VO2): tutto ciò comporta l'aumento della differenza artero-venosa di ossigeno ed una diminuzione significativa della saturazione del sangue venoso misto (SvO2) . In tali condizioni, nelle zone polmonari a basso rapporto V|Q o ad effetto shunt, si determinerà una progressiva desaturazione sul sangue arterioso.
 Fig.1 Fig.1
| L'incremento dell'indice cardiaco indotto e mantenuto stabilmente nel tempo dall'impiego della Dobutamina (7), a motivo dell' effetto inotropo diretto e del miglioramento delle resistenze arteriolari sistemiche e polmonari, consente di accrescere il trasporto di ossigeno in periferia recuperando la stabilizzazione dell'indice di estrazione periferica di ossigeno (EO2= VO2 / DO2) con il relativo aumento della SvO2 e riduzione dell'azione ipossiemizzante sul sangue arterioso delle zone polmonari ad effetto shunt , su cui l'incremento della ventilazione non ha che scarsa efficacia (8,9) : nelle zone polmonari a basso rapporto V\Q, la SaO2 migliora infatti con l'incremento della SvO2 (10) . |
L'incremento della disponibilità
di ossigeno in periferia permette altresì un migliore rifornimento
ai mm. respiratori che aumenteranno la loro resistenza al lavoro
respiratorio con diminuzione progressiva della capnia (3).
Si può affermare che l'assistenza respiratoria, in ossigenoterapia (11) o in supporto di pressione, non garantisce nei pazienti con BPCO ed I.R. il raggiungimento precoce ed ottimale della stabilità degli scambi gassosi e dell'ossigenazione tessutale se nel contempo non si accrescono i parametri emodinamici (DO2 e SvO2): in tali pazienti infatti bisogna assicurare un buon contenuto arterioso di ossigeno, ma soprattuto bisogna garantirne il trasporto e l'adeguata utilizzazione in periferia (12). La Dobutamina, per le sue peculiari caratteristiche farmacodinamiche di inotropo beta-adrenergico, con azione vasodilatatrice periferica, è il farmaco ideale per il raggiungimento dello scopo, in quanto permette di resettare la relazione VO2 - DO2 ( relazione dimostrata anche nei pazienti BPCO (6) ), non comportando maggior consumo di ossigeno per il miocardio, ma anzi favorendone la compliance per riduzione del lavoro; tali parametri non sono ottenibili con la Digosina o la Dopamina (13) (fig.2).
 | Fig.2 |
L'incremento dell I.C. ed il raggiungimento della stabilità cardio respiratoria consentono alla Dobutamina di essere, per efficacia e sicurezza, farmaco di scelta nella terapia medica dell' I.R., anche per gli effetti metabolici sulla produzione di energia a livello mitocondriale del miocardio e dei mm.scheletrici che si mantengono stabili nel tempo persino dopo la sospensione dell'infusione (14).
 fig.3 fig.3
| Il coinvolgimento degli indici emodinamici (15) nel miglioramento e stabilizzazione dell' I.R ipossiemico-ipercapnica, viene da noi espresso dall'attuale esperienza clinica e viene anche confermato dalla disamina di recente letteratura sugli indicatori di prognosi dei pazienti con BPCO (fig.3), ma verrà ulteriormente da noi valutato da studi successivi che includano la misurazione dei parametri emodinamici determinati con cateterismo in corso di BPCO scompensata.
|
BIBLIOGRAFIA
1)Ambrosino N., Nava S., Rubini F: Non invasive mechanical ventilation in thetreatment of acute respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Monaldi Archivies for Chest Desease;1993, 48:144-154
2)Sturani C.: L'insufficienza Respiratoria Acuta dei pazienti con BPCO: Metodiche diventilazione non invasiva. Rassegna Delle Malattie dell'Apparato Respiratorio. 1994: 9: 321-328
3)Lanza V.: Uso della Dobutamina nel trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta del broncopatico cronico. Libro di Testo del Corso di Perfezionamento F.E.E.A. Apr.94,119-126
4)Lanza V.: L'uso della Dobutamina in periodo perioperatorio per la prevenzione dell'ipoperfu- sione d'organo in chirurgia non cardiaca. Minerva Anestesiologica 1995
5)Albert R.K.,Scriien F.,Poincelot F.: Oxygen consuption and transport in stable patients whit COPD. Am.Rev.Resp.Dis,1986 134:678-682
6)Brent N.C.,Matthay R.A.,Mohler D.A.: Relationship between oxygen uptake and oxygen transport in stable patients with COPD. Am.Rev. Resp.Dis.129,1984.682-686
7)Vincent Jl,Roman A,de Baker D, Kahn RJ: Oxygen uptake/supply dependency. Effects of short-term Dobutamine infusion. Am. Rev. Resp.Respir.Dis. 1990;Jun,142:2-7
8)De Michelis, C. Aquilina R,Mirabelli: Correlazione tra portata cardiaca,alterazione del rapporto ventilazione perfusione e ossigenazione tessutale in pazienti con BPCO. Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio.1994.9,297-302
9)Marazzini L: Fisiopatologia e semeiotica funzionale della Respirazione. Ed. Cortina - Gen.92
10)Pierson D.J: Ossigenazione normale e patologica: fisiologia e sindromi cliniche. Respiratory Care. Ed.it. Anno I - n.4: 3-14.
11)Ioli F., Braghiroli A, Donner C.F.: Long term oxygen therapy. Monaldi Archivies Chest Diseas 1994;49;3 Suppl.1,9-12
12)Lorente PA, Renes E, Landin L: Oxygen delivery- dependent oxygen consumption in acute respiratory failure. Critical Care Medicine 1991 Jun.;19: 770-775
13)Shoemaker WC,Appel P, Kram H:Oxygen transport measurements to evaluate tissue perfusion and titrate terapy: Dobutamine and Dopamine effects ..Critical Care Medicine 1991 May ;19:672-688
14)Van den Brand P, Demendts M,: Intermittent Dobutamine Infusion in Severe Chronic Heart Failure in Elderly Patient . Gerontology 1990 ;36;49-54.
15)Yu M, Levy MM,Smith P,: Effect of maximizing oxygen delivery on morbidity and mortality rates in critically ill patients: a peospective,randomizzed, controlled study. Critical Care Medicine. 1993 Jun; 21: 830-838
___________________________________________________________________
3 L'INTOSSICAZIONE
DEL MESE: TENTATO
SUICIDIO PER INGESTIONE DI CLOZAPINA
___________________________________________________________________
In questa sezione di ESIA- Italia curata dal dott. A.PIGNATARO sarà ospitata la descrizione ed il relativo commento di un caso di intossicazione acuta.
TENTATO SUICIDIO PER INGESTIONE DI CLOZAPINA
A. Pignataro, P. De Michele, M. Passafiume, V.Lanza
I farmaci neurotropi sono largamente prescritti e di conseguenza utilizzati per patologie come ansia, depressione, psicosi. Benzodiazepine a parte, il cui consumo riguarda milioni di individui in tutto il mondo, e la cui tossicità è bassa, gli antipsicotici, di impiego più ristretto, presentano una tossicità decisamente superiore e sono all'origine di quadri d'intossicazione più severi. Nel seguente caso clinico viene descritto un quadro d'intossicazione acuta per ingestione di un antipsicotico di recente introduzione nella farmacopea nazionale.
Alle 01.00 del 10 febbraio un uomo dell'età di 35 anni veniva condotto dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale in coma e agitazione psicomotoria. All'esame obbiettivo neurologico il medico di guardia riscontrava un GCS di 9 (nessuna risposta allo stimolo verbale, presenza di risposta allo stimolo algogeno), tremori muscolari diffusi, iperreflessia, midriasi, nistagmo. La pressione arteriosa era 160/100 mmHg e la frequenza cardiaca 120 bpm. La respirazione era laboriosa ed era presente scialorrea.
L'anamnesi del paziente raccolta interrogando i familiari rilevava ripetuti ricoveri in ambiente psichiatrico per psicosi maniaco-depressiva; non erano note altre malattie nè uso di alcolici o sostanze di abuso. Il paziente veniva trattato per la patologia psichiatrica con clozapina 100 mg/die. Il paziente era stato ritrovato nella propria abitazione privo di coscienza ; nessuno dei familiari aveva assistito all'accaduto.
Veniva eseguito un prelievo ematico per la determinazione dei gas nel sangue, uno per gli esami di routine e uno screening tossicologico (benzodiazepine, fenobarbital) ; veniva inoltre eseguito l'ECG che mostrava tachicardia sinusale con sporadiche extrasistoli ventricolari monomorfe.
La terapia intrapresa in urgenza al P.S. consisteva di gastrolusi e carbone attivo (30 g nel SNG), oltre che di ossigeno via maschera (8 l/min) e, dopo incannulamento venoso periferico, di cristalloidi. I valori dell'EAB erano :
| pO2 | 80 mmHg |
| pCO2 | 42 mmHg |
| pH | 7.37 |
| SO2 | 97% |
| HCO3 | 24 |
Un'accurata ricerca nell'abitazione del paziente, richiesta dai sanitari, portava alla scoperta di una confezione di leporex 100 mg cp. (clozapina) nella quale mancavano 25 compresse di farmaco : considerata la prescrizione giornaliera di 100 mg e il recente cambio terapeutico a favore di questa molecola, era verosimile un'assunzione volontaria di circa 2.5 g.
La persistenza delle turbe della coscienza dopo 1 ora dall'arrivo in ospedale imponeva il coinvolgimento dell'anestesista-rianimatore e il trasferimento del paziente nel reparto di terapia intensiva. Qui, i tremori e l'agitazione psico-motoria pur in assenza di contatto verbale con il pz. costringevano il rianimatore all'uso di una sedazione continua con propofol (150-200 mg/h). Il posizionamento di una cannula naso-faringea e l'adozione di elevati flussi di O2 (10 l/min) in maschera garantivano adeguati scambi gassosi e un'ossigenazione soddisfacente (pO2 >90 mmHg). L'incannulamento di una vena centrale tramite un catetere lungo introdotto dalla vena basilica in vena cava superiore e dell'arteria radiale per il monitoraggio cruento della pressione arteriosa continua, nonchè per la determinazione dell'EAB insieme al monitoraggio continuo dell'attività elettrica cardiaca e della pulsiossimetria, completavano l'accoglienza del pz. L'esame obiettivo del torace consisteva di rumori umidi diffusi ; ili addensati e un'obliterazione del seno costo frenico sn. erano presenti alla radiografia del torace. In assenza di una terapia antidotica specifica per la sostanza in causa, si insisteva sulla depurazione del tossico dal tubo gastroenterico con la somministrazione ripetuta di carbone attivo (via SNG) 30 g. ogni 4 ore e di un catartico (solfato di Mg). La necessaria valutazione neurologica del pz. veniva condotta con la sospensione dell'infusione continua del propofol in media ogni 6 ore. Se, dopo circa 12 ore dal ricovero in terapia intensiva, il pz. mostrava al comando verbale un'accenno di risposta, era pur vero che un'estrema agitazione motoria induceva i sanitari alla ripresa della sedazione. Fino a quell'epoca il quadro clinico mostrava le stesse caratteristiche dell'ingresso : scialorrea, tachicardia, midriasi, iperreflessia. La ventilazione spontanea con ossigeno in maschera rimaneva adeguata. Durante le prime 24 ore, le condizioni restavano stazionarie. In 2a giornata la sospensione della sedazione non era seguita da tremori e agitazione e il pz. alla stimolazione verbale rispondeva in modo più adeguato : restava tuttavia spiccata sonnolenza interrotta da bruschi "risvegli". Il miglioramento dell'ossigenazione permetteva la riduzione del flusso di O2 (5 l/min in maschera) ; la pressione arteriosa era normale ma residuava tachicardia sinusale (>120 bpm). Veniva sospeso il carbone attivo. A poche ore dalla cessazione della sedazione, la comparsa di un episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare richiedeva l'impiego di adenosina (6 mg) e di pindololo (0.2 mg) con completa risoluzione. Un graduale recupero della coscienza e delle capacità cognitive conducevano in 3a giornata ad un sensibile miglioramento del quadro clinico : veniva interrotta l'ossigeno-terapia, la terapia infusionale e intrapresa l'alimentazione orale. La mobilizzazione del pz. determinava un nuovo episodio di TPSV (fc>170) trattato anche in quell'occasione con adenosina e pindololo. Una consulenza psichiatrica confermava la patologia psichiatrica del pz. (psicosi maniaco-depressiva) e riconfermava la terapia : clozapina 100 mg/die. L'assenza momentanea dal prontuario farmaceutico dell'ospedale del farmaco prescritto e di conseguenza la mancata somministrazione determinavano in 4a giornata un alterazione dell'equilibrio psichico del pz. che da quel momento, pur essendo consapevole della propria patologia avrebbe rifiutato qualunque terapia. Era necessario pertanto ricorrere ad un altro antipsicotico (promazina 50 mg im) e richiedere un trattamento sanitario obbligato per il trasferimento del pz. in un reparto specializzato.
Dalla scoperta dell'attività antipsicotica della cloropromazina (1952) appartenente alla classe delle fenotiazine e dei butirrofenoni (1959), sono state sintetizzati e introdotti nel commercio migliaia di prodotti chimici con attivita neurolettica. Tutti i neurolettici, tuttavia, anche i più recenti, producono nimerosi effetti collaterali e reazioni avverse a volte molto gravi : morte improvvisa, agranulocitosi, discinesia tardiva, sindrome neurolettica maligna sono alcuni esempi del ristretto margine terapeutico di queste sostanze (1) . La continua ricerca scientifica ha condotto alla scoperta di nuovi antipsicotici con caratterisitche farmacologiche diverse dalle molecole convenzionali. Tra questi, la clozapina (approvata dalla FDA nel 1989) di recente introduzione in Italia, è uno dei più frequentemente impiegati nelle psicosi resistenti o refrattarie al trattamento con i farmaci tradizionali. La clazapina pur essendo stata sintetizzata più di trent'anni fa non era stata proposta per l'uso clinico per la segnalazione di alcuni casi fatali di agranulocitosi in corso di trattamento (2). L'efficacia di questo farmaco nelle forme psicotiche non altrimenti trattabili con i farmaci convenzionali ne ha permesso l'ingresso nel mercato (3).La clozapina è un antipsicotico atipico per la sua affinità ai recettori dopaminergici diversa da quella posseduta dagli altri farmaci antipsicotici. Essa è dotata inoltre d'effetti anticolinergici, antiistaminici, antiserotoninergici e adrenolitici.
Intossicazioni fatali da clozapina sono stati riportati per ingestione di 2.5 g., mentre overdoses da oltre 4 g. si sono risolte positivamente. La sintomatologia acuta è caratterizzata da confusione, agitazione, delirio, iperreflessia, convulsioni, coma, scialorrea, ipotensione, tachicardia, aritmie e depressione respiratoria. Bene assorbita dal tratto gastroenterico, è altamente legata alle proteine plasmatiche (95%), possiede un'emivita di eliminazione di circa 12 ore (range 6-30 h.) e viene completamente metabolizzata a livello epatico in metaboliti inattivi (4).
Il trattamento consiste nel sostegno
delle funzioni vitali mantenendo la pervietà delle vie
aeree, un'adeguata ossigenazione e la ventilazione. L'uso del
carbone attivo e dei catartici è efficace se non superiore
all'emesi e alla gastrolusi. Di fondamentale importanza il monitoraggio
continuo del sistema cardiovascolare e l'impiego delle misure
di supporto necessarie. La sorveglianza dovrebbe essere continuata
per diversi giorni a causa di effetti ritardati. Non esiste un
antidoto specifico per la clozapina e la diuresi forzata, alcalina
o le tecniche di depurazione extrarenale non sono efficaci per
via del metabolismo pressocchè epatico del farmaco.
Nel caso clinico descritto, l'ingestione del farmaco è
stata tale da determinare gravi effetti tossici ; sebbene
non sia stato possibile effettuare il dosaggio plasmatico per
assenza in ospedale di una laboratorio tossicologico adeguatemente
attrezzato, la sintomatologia clinica era tale da imporre al paziente
un trattamento intensivo. Il quadro era peraltro compatibile con
quello determinato dalla clozapina e dal racconto dei familiari
era stato possibile escludere l'assunzione di altre sostanze.
Nè in pronto soccorso, nè in rianimazione si era
provveduto ad effettuare la gastrolusi per via delle condizioni
neurologiche del paziente e della mancata conoscenza dell'epoca
d'ingestione del farmaco. In questi casi riteniamo, se una scadente
ventilazione e ossigenazione non richiedono prima l'intubazione
endotracheale e la ventilazione meccanica, più sicuro ed
efficace il posizionamento di un sondino naso-gastrico per verificare
la quantità e natura del liquido gastrico e la somministrazione
di carbone attivo (1 g/kg). Nonostante l'assunzione di una sostanza
psicotropa in grado di deprimere il SNC e il sistema respiratorio,
è stato necessario somministrare un sedativo/ipnotico per
controllare il paziente ; il propofol a basse dosi in infusione
continua è un farmaco pilotabile che, possedendo una rapidità
e una brevità d'effetto, consente rapidi e ripetuti riaggustamenti
della velocità di somministrazione e valutazioni neurologiche
già pochi minuti dopo la sua interruzione. Pur ricorrendo
ad elevati flussi di ossigeno, non si è ritenuto di procedere
al controllo delle vie aeree con l'intubazione e la ventilazione
meccanica, in quanto la rimozione della CO2 era sufficiente.
Le 2 crisi di TPSV presentate dal paziente,
avvenute entrambe tardivamente dall'epoca dell'intossicazione,
testimoniano l'importanza del monitoraggio emodinamico prolungato,
mentre l'uso di antiaritmici a breve durata d'azione permette
di minimizzare i rischi di blocchi cardiaci possibili con la clozapina.
Nella fase di recupero, un vuoto terapeutico di clozapina aveva
determinato un effetto rebound con crisi psicotica acuta e ricorso
al trattamento coatto per il trasferimento del paziente in un
centro psichiatrico.
La clozapina, pur di recente introduzione
nell'uso clinico in Italia, viene ampiamente utilizzata in ambito
psichiatrico. Al pari di altri farmaci antipsicotici presenta
un ristretto margine terapeutico con numerose reazioni avverse
già a dosi terapeutiche. A dosi tossiche (> 2 g.), la
clozapina determina quadri clinici minacciosi per la vita. In
mancanza di un antidoto specifico la terapia sintomatica di sostegno
delle funzioni vitali e la depurazione digestiva costituiscono
l'approccio più indicato per fronteggiare l'intossicazione.
Bibliografia
1) Anderson ES, Powers PS: NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME ASSOCIATED WITH CLOZAPINE USE. Journal of Clinical Psychiatry 1991; 52(3):102-4
2) Gerson SL, Meltzer H: MECHANISMS OF CLOZAPINE-INDUCED AGRANULOCYTOSIS. [REVIEW]. Drug Safety 1992; 7 Suppl 1:17-25
3) Buch DL: CLOZAPINE: A NOVEL ANTIPSYCHOTIC. [REVIEW]. American Family Physician 1992; 45(2):795-9.
4) Meeker JE, Herrmann PW, Som CW, Reynolds PC: CLOZAPINE TISSUE CONCENTRATIONS FOLLOWING AN APPARENT SUICIDAL OVERDOSE OF CLOZARIL. Journal of Analytical Toxicology 1992; 16(1):54-6
___________________________________________________________________
4 MANUALI DI ANESTESIA:LAMINECTOMIA PER ERNIA DISCALE ___________________________________________________________________
Questa rubrica, curata dal dott. Lelio Guglielmo, presenta i protocolli anestesiologici adottati ,nelle varie specialità chirurgiche , dal Servizio di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale Buccheri La Ferla. Questi manuali che sono il frutto di studi e dell'esperienza di oltre 15 anni di attività anestesiologica non pretendono ovviamente di avere un carattere "universale" . E' evidente altresì che l'applicazione delle procedure descritte va valutata criticamente in relazione al proprio ambiente di lavoro. La parte riguardante le considerazioni chirurgiche è stata realizzata in collaborazione con i chirurghi delle varie specialità, operanti nel nostro ospedale.
Qualsiasi commento o critica è bene accetta e deve essere inviata a leliobuc@mbox.vol.it. oppure alla redazione LANZA@mbox.unipa.it
 | LAMINECTOMIA PER ERNIA DISCALE |
Considerazioni chirurgiche
| La laminotomia (parziale rimozione della lamina) e la laminectomia (completa rimozione della lamina) lombare sono procedure atte a decomprimere gli elementi neurali del midollo lombare realizzate mediante un approccio posteriore. | |
Il livello dove operare può essere confermato da una verifica radiologica intraoperatoria servendosi di un ago inserito nello spazio interverterbrale scelto. Attraverso una incisione verticale paraspinosa, viene esposta la fascia lombodorsale, vengono scollati i muscoli paraspinosi, si esegue la flavectomia e si espone la lamina dei segmenti da decomprimere.
 |
Vengono identificati i reperi ossei. I frammenti ossei vengono rimossi con una strumentazione apposita. Il chirurgo deve avere cura di non danneggiare la sottostante dura madre. Se essa viene perforata deve essere riparata. Se deve essere rimosso il disco intervertebrale la dura madre viene spostata, l'anulus viene inciso e il disco viene asportato a frammenti. Durante questa fase c'è il rischio di danneggiare le strutture retroperitoneali ed in particolare la vena cava inferiore.
Più frequentemente può subentrare un sanguinamento peridurale non facile da controllare. Infine dopo un'accurata emostasi i vari strati vengono suturati.
Diagnosi preoperatoria abituale:
radicolopatia, ernia del disco, spondilosi, spondilolistesi.
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE
DEI PAZIENTI
| Età | 15-85a. (di solito 30-60a.) |
| Maschi/Femmine
Eziologia | 3/2
Degenerativa Neoplastica Traumatica Infettiva |
SOMMARIO DELLE PROCEDURE
|
|
Considerazioni anestesiologiche
PREOPERATORIO
La chirurgia del tratto lombare è
molto comune a causa della frequente erniazione del disco intervertebrale
lombare che causa una compressione dell'adiacente midollo spinale
e delle radici.. In generale questi pazienti sono sani ed in buone
condizioni generali.
App.neurologico: I pazienti con ernia al disco generalmente lamentano dolore lombare con irradiazione ad uno o entrambi gli arti. Normalmente traggono un beneficio temporaneo da dispositivi di sostegno lombare, calore o da terapie farmacologiche con antinfiammatori. Se la compressione continua il paziente può sviluppare debolezza e atrofia del gruppo muscolare specifico. Questi segni non sono comunque specifici di ernia discale e possono essere causati da una cisti o tumore spinale. Attualmente la diagnosi viene posta con la TAC o la RMN.
Premedicazione della veglia: La premedicazione
è molto utile in questa popolazione di pazienti che normalmente
ha dolore ed è molto in ansia per l'intervento. La nostra
premedicazione prevede normalmente la somministrazione di 1-2
mg.di Tavor la sera e la mattina alle 6. Se è presente
dolore si utilizza il Voltaren o la Meperidina.
INTRAOPERATORIO
| Premedicazione | standard |
| Emodiluizione | utile se è prevista una laminectomia estesa. |
| Anestesia | AG. Il paziente viene intubato sulla barella e poi viene trasferito in posizione prona sul lettino operatorio. Un'anestesia e soprattutto un rilasciamento neuromuscolare adeguati (controllo frequente della curarizzazione) sono necessari per evitare movimenti improvvisi del paziente che possono interferire con la chirurgia. E' utile mantenere il paziente in una condizione di ipotensione controllata al fine di ridurre al minimo il sanguinamento del campo operatorio. |
| Accessi venosi | 1 cateterino 16 0 18 g |
| Monitoraggio | FC, SaO2, tcPO2-PCO2, pressione arteriosa cruenta, diuresi oraria |
| Posizionamento: | Posizionare dei cuscinetti sui punti di compressione ed in particolare
attenzione a: - occhi ed orecchie - seni e genitali - addome libero - tratto cervicale della colonna |
Complicanze |
ß PA Legata alla ß del ritorno venoso per la posizione emorragia Per ingorgamento v. peridurali se compressione addominale o lesione vascolare. Se l'ipotensione persiste nonostante il riempimento e l'Hb si riduce
sospettare un sanguinamento retroperitoneale |
| Il posizionamento sul lettino in posiziona prona dovrebbe essere realizzato da uno staff (ortopedico, anestesista, ausiliari) abituato. Il tubo endotracheale deve essere fissato al viso con cura per evitare una possibili estubazione durante le manovre di posizionamento. Non dimenticare di posizionare il SNG ed il fonendoscopio esofageo prima di girare il paziente. Il paziente viene posizionato nella posizione " crouch", inginocchiata con le natiche poggiate contro un sostegno, le ginocchia e le anche flesse, l'addome libero con il torace e le spalle poggiate su un cuscino. Le braccia vengono flesse e portate verso l'alto. Il collo deve essere leggermente flesso mentre la testa non deve subire una rotazione o una fessione eccessive. | 
|
| POSTOPERATORIO | |
| Complicanze | Emorragia
ß PA L. nervosa |
| Trattamento del dolore | Diclofenac 75 mg x 2 i.m. o Meperidina 50 mg x 3 i.m. |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Informazioni sulla rivista
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE-Italia-
Educational Synopses in Anesthesia and Critical Care Medicine-Italia costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo.A cura della redazione sarà inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese.La rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta
inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione italiana" indirizzato a LANZA@MBOX.UNIPA.IT
La rivista pubblica rewiews e lavori originali compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici. Le reviews includono argomenti per l' Educazione Medica Continua (EMC), articoli di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed anche brevi comunicazioni.La guida per gli autori può essere consultata collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo:
http://mbox.unipa.it/~lanza
utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia
Oppure può essere richiesta inviando un messaggio a
lanza@mbox.unipa.it
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana
E' anche ottenibile attraverso World-Wide Web WWW: L' URL per questo numero di ESIA è:
http://mbox.unipa.it/~lanza/esiait/esit9702.txt
Il nome della rivista è
esitaamm, dove aa è l'anno ed mm il mese
(per esempio questo numero è esit9702.txt)
LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA
DIRETTORE
Vincenzo LANZA
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo LANZA@MBOX.UNIPA.IT
Terapia Intensiva
Antonio Braschi
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1
Policlinico S. Matteo - IRCCS Pavia
Anestesia Cadiovascolare
Riccardo Campodonico
Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica
Azienda Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it
Anestesia e malattie epatiche
Andrea De Gasperi
Gruppo trapianti epatici / CCM
Ospedale Niguarda - Milano
Medicina critica e dell'emergenza
Antonio Gullo
Professore di Terapia Intensiva
Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva-Università di Trieste
Anestesia ed informatica
Vincenzo Lanza
Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo
Tosssicologia
Carlo Locatelli
Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di Pavia
Fondazione Scientifica
"Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"
Pavia
Terapia Antalgica e Cure Palliative
Sebastiano Mercadante
Aiuto del Servizio d'Anestesia e Rianimazione
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Palermo