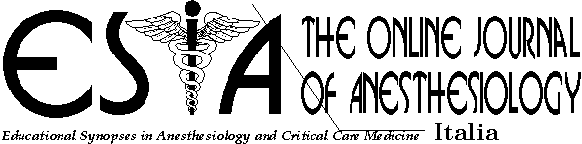
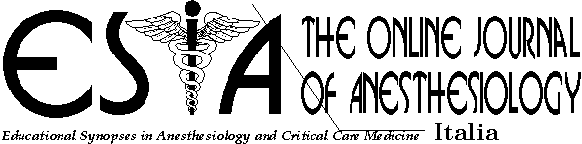
ISSN 1080-3521
EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY
and
CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -
Il giornale Italiano online di anestesia Vol 9 No 02 Febbraio 2004
Vincenzo Lanza, MDServizio di Anestesia e RianimazioneOspedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo, ItalyE-mail: lanza@mbox.unipa.it |
Keith J Ruskin, MDDepartment of Anesthesiology Yale University School of Medicine333 Cedar Street, New Haven, CT 06520 USAE-mail: ruskin@gasnet.med.yale.edu |
Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line può essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine |
|
La redazione di Esia-Italia dedica
alcuni suoi numeri alla pubblicazione dei lavori che hanno costituito parte del
materiale didattico del Corso "Problemi Cardiologici in Anestesia e Terapia
Intensiva" tenutosi nel Marzo 2003 presso il CEFPAS (Centro per la Formazione
Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) sito in
Caltanissetta (Sicilia). Questo è uno dei corsi organizzati in collaborazione
con la FEEA (Fondazione Europea di Insegnamento in Anestesiologia) e rappresenta
uno dei diversi momenti formativi di un vasto percorso didattico che spazia
ampiamente tra le diverse aree di interesse nel campo dell'Anestesia e della
Terapia Intensiva.
In futuro Esia-Italia ospiterà altri iter formativi monotematici nella certezza
di incontrare la continua necessità di studio dei suoi Lettori che potranno così
soddisfare in modo sempre gratuito e immediato le proprie esigenze di formazione
anche non spostandosi dal proprio posto di lavoro.
dal Corso "PROBLEMI CARDIOLOGICI IN
ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA" - CORSO FEEA 2 - marzo 2003 CEFPAS
1 IL MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO DEL PAZIENTE OPERATO
2 EMODINAMICA INTRACARDIACA: TECNICHE DI MISURA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI
3 FATTORI DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA
4
ALTERAZIONI DELLA GITTATA CARDIACA INDOTTE
DALL'ANESTESIA: PREVENZIONE E TRATTAMENTO CON L'USO DI INOTROPI
_______________________________________________________
IL MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO DEL PAZIENTE OPERATO
_______________________________________________________
R. Larbuisson (Belgio)
L'elettrocardiogramma od ECG è la rappresentazione grafica delle fluttuazioni di potenziale che rappresentano la somma algebrica dei potenziali d'azione delle singole fibre miocardiche.
Il potenziale d'azione cellulare è definito come una corrente elettrica, che penetra all'interno della cellula, dovuta al movimento di ioni attraverso la membrana cellulare, che diviene permeabile ad essi, dopo essere stata depolarizzata fino ad un livello critico detto soglia. In base alla loro localizzazione, le cellule cardiache hanno differenti potenziali, differenti soglie, e dei potenziali d'azione di diversa morfologia. Tali potenziali d'azione sono stati raggruppati in potenziali a risposta rapida, come per la miocellula atriale, ventricolare e del Purkinje ed in potenziali a risposta lenta come per la cellula del nodo del seno e del nodo atrio- ventricolare.
Nella fibra del Purkinje, il potenziale d'azione inizia attraverso una corrente rapida di sodio (fase 0), che cessa bruscamente (fase 1). Durante il plateau del potenziale d'azione (fase 2), il potenziale di membrana dipende da una corrente di ingresso lento di calcio e/o di sodio e da una corrente di uscita di potassio. Quest'ultima è a lenta insorgenza, ma si attiva in funzione del tempo e, quando è al massimo, comporta una rapida ripolarizzazione cellulare (fase 3).
A livello del nodo del seno o del nodo atrio-ventricolare, il potenziale d'azione è a risposta lenta ed ha, come caratteristica, una soglia dell'ordine di - 50 - 35 mV, una velocità di ascesa più lenta, un'ampiezza del potenziale d'azione ridotta, una breve durata del potenziale d'azione ed un recupero ritardato dell'eccitabilità. La funzione principale del nodo seno-atriale è quella di pace-maker del cuore; si può depolarizzare da 60 a 100 volte al minuto. Se il nodo seno-atriale è insufficiente, il nodo atrio-ventricolare prende il comando con una frequenza da 45 a 50 battiti al minuto. Infine si attivano le fibre del Purkinje con una frequenza da 30 a 40 battiti al minuto.
L'impulso nervoso trova il suo punto di partenza a livello del nodo seno-atriale, che è costituito da tessuto nervoso specializzato posto nello strato subendocardico alla giunzione fra la vena cava e l'atrio destro. Da qui, l'impulso guadagna il nodo atrio-ventricolare, attraverso il muscolo atriale. Questo nodo è posto sulla superficie endocardica del setto interatriale, faccia atriale destra, vicino alla valvola tricuspide, esattamente sotto l'imbocco del seno coronarico. L'impulso arriva poi al fascio di His, posto sul lato destro del setto interatriale, al di sopra del setto interventricolare; il fascio di His si divide in un braccio destro ed uno sinistro, posti ciascuno ai lati del setto interventricolare. La branca sinistra si divide in una parte anteriore o superiore ed una posteriore od inferiore. Successivamente ciascuna branca si suddivide nelle fibre del Purkinje, che coprono lo strato subendocardico dei due ventricoli.
L'ECG studia le forze elettriche prodotte dal miocardio durante il ciclo cardiaco
(fig. 1).
L'onda P rappresenta la depolarizzazione atriale;l'intervallo P-R il tempo di conduzione
atrio-ventricolare, la cui durata è inferiore a 0.20 sec.; il complesso QRS riflette la
depolarizzazione ventricolare e dura meno di 0.10 sec.; il tratto ST e l'onda T rappresentano la
ripolarizzazione ventricolare. L'intervallo QT misura il tempo di conduzione di depolarizzazione e di
ripolarizzazione, che deve essere di durata inferiore alla metà
dell'intervallo R-R.
|
|
| Figura 1 |
Il sistema elettrocardiografico è costituito da 5
elettrodi, posti ciascuno all'estremità di uno dei
quattro arti ed uno sulla parete toracica. L'elettrodo posto al piede destro è quello di
riferimento. Ciascuna derivazione misura il
potenziale elettrico tra due elettrodi e tra un elettrodo e
la somma degli altri (triangolo di Einthoven) (fig.
2).
|
|
|
| Figura 2 - A destra: Triangolo di Einthoven. Le perpendicolari calate dal punto di mezzo di ciascuno dei lati del triangolo equilatero si incontrano al centro dell'attività elettrica. Al centro: Calcolo del vettore QRS medio. In ognuna delle tre derivazioni, si misura, partendo dal punto mediano del lato rappresentante la derivazione, un segmento uguale all'altezza dell'onda R meno l'altezza massima dell'onda negativa del complesso QRS. Una freccia che va dal centro dell'attività elettrica al punto d'incontro delle tre perpendicolari calate dalle estremità dei tre segmenti, misurati nella maniera anzi detta sui tre lati del triangolo, rappresenta la grandezza e la direzione del vettore QRS medio. A destra: Assi di riferimento, per determinare la direzione del vettore. |
|
Le derivazioni standard vengono ottenute da
punti distanti del cuore, posti sullo stesso piano
frontale del corpo. Le derivazioni precordiali sono
unipolari ed utilizzano gli elettrodi dei quattro arti per realizzare un riferimento centrale
indifferente. L'elettrodo attivo è uno delle sei posizioni toraciche. Le derivazioni aVR, aVL ed aVF usano
gli elettrodi degli arti di funzione unipolare, mentre gli elettrodi dei due arti realizzano un
riferimento centrale indifferente e il terzo è l'elettrodo attivo (fig.
3). Durante la lettura di un elettrocardiogramma occorre esaminare in successione: la
frequenza cardiaca, il ritmo, l'asse elettrico, l'onda P, l'intervallo PR, il complesso QRS, il segmento
ST, l'onda T, l'onda V e l'intervallo QT.
|
|
| Figura 3 |
Il monitoraggio elettrocardiografico del paziente operato durante le fasi pre- peri- e
post-operatoria consente di apprezzare le turbe del ritmo, le turbe di conduzione,
l'ischemia miocardica, le affezioni pericardiche e le modificazioni elettrolitiche o farmacologiche.
Alcuni dati possono essere ottenuti con maggiore precisione avvalendosi dell'ECG da sforzo o
di registrazioni elettrocardiografiche di lunga durata. Nel periodo peri-operatorio, la
diagnostica delle turbe del ritmo e di quelle di conduzione è più facile mediante la derivazione DII,
che evidenzia l'onda P, nonché un'eventuale ischemia del ventricolo destro e della parete
inferiore del ventricolo sinistro. La derivazione V5 consente di rilevare un'ischemia sopraggiunta
nei territori anteriore e laterale del ventricolo sinistro; essa può essere ottenuta con l'aiuto di 5
o di 3 elettrodi. Se il cavo non è provvisto di 3 elettrodi, si posiziona quello del braccio sinistro in V5, quello
del braccio destro sulla spalla ed il terzo al piede sinistro. Quando il selettore è in posizione DI, si esplora la parete ant., quando è in DII la parete inf.
Molti artefatti interferiscono con la traccia ECG sull'oscilloscopio. Ciascun apparecchio
di monitoraggio è, pertanto, fornito di filtri a bassa o ad elevata frequenza, che
possono comportare modificazioni del segmento ST.
I movimenti respiratori od altro, un cattivo contatto degli elettrodi possono portare ad
instabilità della linea di base. Un filo spezzato dell'elettrodo simula un flutter atriale. L'elettrobisturi
altera totalmente l'elettrocardiogramma.
Il numero di pazienti portatori di pace-maker aumenta ogni anno. Gli studi anatomici
del tessuto di conduzione permettono di spiegare una evoluzione progressiva del passaggio
del blocco parziale al blocco completo di conduzione. Tra le cause organiche di blocco vi è
la degenerazione fibrosa primaria e poi le affezioni di tipo ischemico. Tra le cause funzionali di blocco vi è un aumento del tono vagale, l'iperkaliemia,
l'impregnazione da digitale, chinidina, procainamide o betabloccanti.
Il tipo di pace-maker è importante.
Un pace-maker asincrono scarica ad un ritmo indipendente dall'attività elettrica cardiaca con rischio di competizione tra i due ritmi e passaggio in fibrillazione ventricolare. Il pace-maker sincrono a stimolazione ventricolare individua il complesso QRS e scarica nel periodo refrattario assoluto. Il pace-maker sincrono ad inibizione ventricolare è inibito dall'attività elettrica normale del cuore. Nel caso del pace-maker sincrono atriale, grazie al gioco dei due elettrodi, è identificata l'onda P ed il ventricolo è stimolato dopo un periodo refrattario prolungato. Viceversa nel caso di un pace-maker sequenziale, dapprima sono stimolati gli atri a contrarsi e dopo un periodo refrattario variabile è stimolato il ventricolo. Questo tipo può essere convertito in modo asincrono ventricolare con l'applicazione di una calamita.
Oggi un pace-maker è definito con cinque lettere. La prima lettera identifica la camera stimolata, la seconda la camera identificata. La lettera "V" indica il ventricolo, la lettera "A" l'atrio, la lettera "D" le due camere. La terza lettera definisce la risposta. La lettera "I" se il pace-maker funzione secondo la modalità di inibizione, la lettera "T" secondo la modalità di stimolazione, la lettera "D" per entrambe le modalità, la lettera "O" per le altre modalità.
La quarta lettera identifica il tipo di programmazione possibile. La lettera "P" se è programmabile un solo parametro (ritmo, segnale). La lettera "M" se sono programmabili più parametri. La lettera "R" se il pace-maker è di tipo "rate responsive" o adattabile al ritmo.
La quinta lettera identifica delle funzioni tachiaritmiche speciali. La lettera "P" se il pace-maker funziona secondo una modalità di pacing come il "pace-maker antitachy", la lettera "S" se produce uno shock come il pace defibrillante e la lettera "D" se funziona secondo le due modalità.
I pace-makers a ritmo adattabile utilizzano variabili fisiologiche per modificare il ritmo di stimolazione. Il pace-maker sensibile ai movimenti identifica i movimenti corporei attivi o passivi grazie a un cristallo piezoelettrico incorporato nel suo contenitore. Così, durante un'anestesia generale, il ritmo del pace-maker può aumentare a seguito di una variazione posturale del paziente, di una manipolazione chirurgica vigorosa, del brivido postoperatorio, di crisi convulsive, di un elettroshock, di contrazioni muscolari legate alla succinilcolina o ad altri agenti anestetici endovenosi. Il pace-maker sensibile al QT misura l'intervallo tra lo stimolo e l'onda T attraverso il sensore dell'estremità della sonda ventricolare. Così, durante un'anestesia generale, tutti i farmaci che modificano l'onda T e l'intervallo QT modificano la risposta ritmica del pace-maker. E' il caso dei betabloccanti, degli antiaritmici, delle variazioni del pH, del potassio sierico o degli anestetici locali.
Il pace-maker sensibile alla respirazione registra con misurazioni di impedenza elettrica tutte le variazioni della frequenza respiratoria e del volume corrente. Così, durante un'anestesia generale, bisognerà fare attenzione alle variazioni apportate con la respirazione artificiale.
Il pace-maker sensibile alla temperatura misura, grazie a un termistore situato al livello della sonda, le riduzioni di 0.2°C della temperatura corporea all'inizio di un'attività fisica a causa dell'aumento del ritorno venoso dai vasi periferici. Così, durante un'anestesia generale, la temperatura corporea che diminuisce ed una perfusione rapida di liquidi da una via centrale possono influenzare il pace-maker.
Il pace-maker sensibile alla contrattilità miocardica misura, grazie a un transduttore di pressione incorporato all'elettrodo, il dp/dt del ventricolo destro. Così, durante un'anestesia generale, il ritmo del pace-maker può essere modificato dai cambiamenti di pressione del ventricolo destro legati a modificazioni posturali, alla ventilazione a pressione positiva, a compressioni della vena cava inferiore, a perfusione rapida da una via centrale od alla somministrazione rapida di farmaci simpaticomimetici.
Il pace-maker sensibile alla saturazione di ossigeno ne misura i cambiamenti al livello del sangue venoso misto grazie ad una cellula fotosensibile situata al livello dell'elettrodo. Così, durante un'anestesia generale, modificazioni della saturazione di ossigeno possono essere legate a una riduzione del metabolismo o ad una riduzione dell'estrazione e modificare il ritmo del pace-maker.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Cardiac Anesthesia J.A.Kaplan - Grune et Stratton
2. Le coeur J.W.Hurst - Masson
3. A practice of anaesthesia Churchill-Davidson - Saunders
4. Manual of Anesthesia J.Snow - Little Brown and Company
5. La maladie coronarienne Cachera-Bourassa - Flammation
6. L'anesthésie du coronarien J.Marty, P.Coriat - Masson
7. Rate-responsive pacemakers an anaesthesia - C.Andersen, Anaesthesia 1990, 45:472-476
_______________________________________________________
EMODINAMICA INTRACARDIACA:
TECNICHE DI MISURA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI
_______________________________________________________
R. Larbuisson
Introduzione
Lo studio dell'emodinamica intracardiaca comprende il rilevamento delle
pressioni intracardiache, dei volumi delle cavità cardiache, della gittata cardiaca e delle
resistenze intra ed extracardiache. Tali parametri presentano delle interrelazioni
importanti. Inoltre varie modificazioni a livello cardiaco, pericardico o della gabbia toracica
possono interferire sullo studio dell'emodinamica cardiaca.
Attività
meccanica cardiaca
Esistono quattro fattori determinanti che influenzano l'attività meccanica cardiaca:
il precarico, il postcarico, la frequenza cardiaca e la contrattilità.
Nel ventricolo integro, il precarico è la forza che distende la cavità ventricolare durante la diastole. Il volume di eiezione aumenta proporzionalmente al grado della pressione diastolica. Viene applicata così la legge di Starling secondo cui la forza di contrazione di una fibra muscolare dipendente dalla lunghezza iniziale di questa fibra. Per analogia nella curva di funzione ventricolare, per la pressione capillare polmonare bloccata alla pressione ventricolare sinistra di fine diastole, si ignora l'onda atriale "a" che eleva la pressione di fine diastole al di sopra della pressione diastolica ventricolare sinistra media. Questo meccanismo è un vantaggio per il paziente in quanto può aumentare la sua pressione ventricolare sinistra di fine diastole senza aumentare la pressione atriale sinistra media, meccanismo che evita di sovraccaricare il circolo polmonare e dunque il rischio di edema polmonare. Questo meccanismo è molto importante nei pazienti con una compliance cardiaca ridotta per ipertrofia ventricolare sinistra, affezioni miocardiche o infarto. Le curve costruite in funzione della pressione telediastolica ventricolare sinistra (PTDVS) suppongono che quest'ultima rifletta direttamente il volume telediastolico, costituendo una relazione inscindibile. In effetti la relazione pressione-volume di un ventricolo non è mai fissa poichè può essere alterata da:
La pressione vigente nei grossi vasi venosi a livello toracico è definita pressione venosa centrale (PVC). La morfologia della curva di pressione è molto vicina a quella della pressione atriale destra. Normalmente non c'è un gradiente di pressione tra i grossi vasi venosi e l'atrio destro. Esistono, a livello toracico delle oscillazioni ritmiche della pressione venosa che sono sincrone con le variazioni delle pressioni intratoraciche.
A livello dell'atrio destro, la morfologia della curva di pressione comprende sei irregolarità. Ciononostante si distinguono solamente le onde "a" e "v". I valori normali a riposo delle onde "a" e "v" vanno da 2 a 10 mmHg. A livello atriale il valore medio di pressione è compreso tra 0 e 8 mmHg. A livello del ventricolo destro, la sistole ventricolare inizia con la contrazione isometrica con una rapido aumento della pressione sino all'apertura della valvola polmonare. Al momento dell'eiezione lenta la pressione diminuisce progressivamente. All'inizio della diastole, la pressione intracavitaria diminuisce e la valvola polmonare si chiude. La fase di rilassamento isometrico è separata dalla fase di riempimento rapido dall'apertura della tricuspide. La pressione sistolica ventricolare destra in condizioni normali varia da 15 a 30 mmHg, la telediastolica da 0 a 8 mmHg e la media da 5 a 25 mmHg.
A livello dell'arteria polmonare, tra l'apertura e la chiusura della valvola polmonare, le curve arteriose polmonari e ventricolari destre sono sovrapponibili. Durante la diastole, la pressione dell'arteria polmonare si riduce lentamente sino ai suoi valori telediastolici. La pressione sistolica dell'arteria polmonare varia normalmente tra 15 e 30 mmHg, la telediastolica tra 3 e 12 mmHg e la media tra 9 e 16 mmHg.
A livello capillare polmonare, la morfologia della curva di pressione ricorda quella atriale per la presenza delle onde "a" e "v". I valori normali delle onde "a" e "v" vanno da 3 a 15 mmHg. La pressione capillare media varia da 1 a 10 mmHg. A livello dell'atrio sinistro, la morfologia della curva di pressione ricorda quella dell'atrio destro. I valori normali, a riposo, della pressione atriale media sinistra variano da 4 a 12 mmHg.
A livello del ventricolo sinistro, la morfologia della curva di pressione ricorda quella del ventricolo destro, sia nella componente sistolica che in quella diastolica. La sola differenza risiede nel regime dei valori pressori. La pressione sistolica ventricolare sinistra normale varia da 100 a 120 mmHg, la telediastolica da 4 a 12 mmHg. A livello della radice aortica, la morfologia della curva di pressione ricorda quella dell'arteria polmonare, sia in fase sistolica che in quella diastolica. L'onda dicrota è comunque generalmente più marcata. Un'altra differenza sta nei livelli pressori: la pressione aortica sistolica normale varia da 100 a 120 mmHg, la diastolica da 70 a 90 mmHg. La pressione capillare effettiva corrisponde alla pressione capillare di filtrazione.
Quando si gonfia il palloncino di un catatere di Swan-Ganz, si può notare facilmente che la variazione di morfologia della curva di pressione avviene in due tempi. All'inizio si ha una caduta rapida della pressione seguita da una riduzione più progressiva. Se si considera che la circolazione polmonare comprende una resistenza precapillare localizzata tra l'arteria polmonare ed il sito della pressione capillare effettiva, la pressione capillare cade alla pressione capillare bloccata a causa di una resistenza postcapillare.
Al momento dell'occlusione dell'arteria polmonare, la traccia della pressione mostra une rapida caduta sino alla pressione capillare effettiva, seguita da una diminuzione più lenta sino al valore della pressione capillare bloccata. La caduta rapida corrisponde alla riduzione della resistenza precapillare mentre la diminuzione lenta è conseguenza della riduzione della resistenza post-capillare.
Da questo momento la pressione capillare effettiva corrisponde alla pressione
microvascolare, rappresentando la principale forza di filtrazione che è responsabile della
formazione dell'edema polmonare. In condizioni patologiche, se la resistenza maggiore è precapillare,
al momento del gonfiamento del palloncino, la pressione cade immediatamente a dei
valori prossimi alla pressione di incuneamento mentre se è maggiore la resistenza
postcapillare allora la pressione di incuneamento è vicina alla pressione arteriosa polmonare
sistolica. Quindi vari farmaci o condizioni particolari possono influenzare la circolazione polmonare.
La localizzazione dell'estremità del catetere non è priva di importanza. In effetti, la
circolazione polmonare è dipendente dalla gravità con una distribuzione, in ortostatismo, apico-basale
del flusso ematico polmonare.
West ha descritto tre zone che rapportano il sistema cardiovascolare ed il sistema
respiratorio sotto forma di un'equazione che prende in considerazione la pressione alveolare, la
pressione arteriosa polmonare e la pressione venosa polmonare. Sarebbe utile parlare così di
pressioni transmurali. Le cavità cardiache e il circolo polmonare sono situati all'interno del
torace. Dunque il loro regime pressorio è influenzato dalle variazioni cicliche della
pressione intratoracica secondarie alla respirazione o alla ventilazione. La pressione transmurale
è quindi uguale alla differenza tra le pressioni che vigono all'interno e quelle che
vigono all'esterno di queste strutture vascolari. Perciò la pressione extravascolare differisce
secondo il carattere alveolare o extra-alveolare dei vasi. Così se i capillari, come vasi alveolari,
sono esposti alla pressione alveolare, la cavità cardiache, strutture extra-alveolari, sono
esposte alla pressione pericardica assimilate quindi alla pressione pleurica che, in clinica, è
utilizzata per misurare la pressione esofagea.
Quando il palloncino dello Swan-Ganz viene gonfiato,
la pressione registrata chiamata pressione capillare polmonare bloccata è uguale alla
pressione venosa polmonare, equivalente alla pressione atriale sinistra media e alla pressione
telediastolica ventricolare sinistra. Queste equivalenze non sono assolute, e le correlazioni
PTDVS-PCP e PAS-PCP non sono corrette. Quindi l'identità quasi completa tra PAS e PCP
scompare progressivamente con l'aumento delle pressioni di riempimento sino a non aver più
significato con una PCP più elevata di 25 mmHg. Si può stimare senza problemi generalmente la
PCP, la PAS e la PTDVS misurando la pressione telediastolica dell'arteria polmonare nei
soggetti con una funzione cardio-respiratoria normale, nei casi di shock ipovolemico, tossico o
nelle ipossiemie moderate, cioè con delle PaO2 superiori a 60 mmHg. Al contrario, esiste
una discrepanza netta tra la PTDAP e le pressioni di riempimento sinistre allorchè le
resistenze arteriose polmonari sono elevate in maniera acuta o permanente. La discrepanza è
evidente anche in caso di tachicardia superiore a 120/min poichè il raggiungimento delle pressioni
per trasmissione retrograda non ha tempo per effettuarsi. Se la PAD ha poca influenza
sulla PTDVS, di contro possiede una notevole importanza in tutte le patologie che interessano
la funzione ventricolare destra. Per quel che concerne l'interpretazione dei risultati è
impossibile pensare che le variazioni di pressione, alla punta del catetere, siano integralmente
riprodotte attraverso il sistema. Il valore di pressione sarà più o meno falsato dai tubi di
collegamento prima che il segnale venga catturato, dando dei risultati imprecisi. In effetti, il
sistema elettronico riproduce fedelmente le pressioni deformate che afferiscono all'apparecchio.
La complessità del circuito idraulico rappresentato dalle tubature è la sorgente principale
di distorsione e può avere un effetto nefasto sulla risposta in frequenza del sistema. Se
la risonanza o frequenza naturale è il numero di vibrazioni al secondo, tutto il sistema
vibra quando l'onda di pressione trasmessa possiede una componente in cui la frequenza è
uguale alla risonanza del sistema. Quindi, per assemblare un sistema, al fine di evitare
ogni risonanza, la frequenza naturale del sistema dovrà essere quanto più lontana dalle
componenti della frequenza del segnale trasmesso.. I fenomeni di smorzamento possono
essere prodotti da vari fenomeni che deformano la curva di pressione come ad esempio la
presenza di bolle d'aria, prolunghe troppo elastiche o troppo lunghe, un catetere di diametro
troppo piccolo.
Interpretazione dei risultati
La frazione d'eiezione di un ventricolo è la differenza tra il volume diastolico e sistolico rapportato al volume diastolico. Esistono tre metodi di misura relativamente difficili da applicare o ripetere al letto del paziente. Si tratta dell'angiografia, della scintigrafia nucleare delle cavità e dell'ecocardiografia. Teoricamente una curva caraterristica della gittata cardiaca ottenuta con la termodiluizione fornisce sufficienti informazioni per calcolare il volume espulso, la frazione d'eiezione e quindi il volume ventricolare destro. Questo tipo di misura è particolarmente interessante nell'infarto ventricolare destro, nell'embolia polmonare, nell'insufficienza respiratoria acuta, nella sepsi, nelle ustioni estese, nella sostituzione valvolare della mitrale con ipertensione polmonare, situazioni queste dove il post-carico del ventricolo destro è elevato.
Abbreviazioni:
PTDVS = pressione telediastolica ventricolo sinistro
PCP = pressione capillare polmonare
PAS = pressione atriale sinistra
PTDAP = pressione telediastolica arteria polmonare
PAD = pressione atriale destra